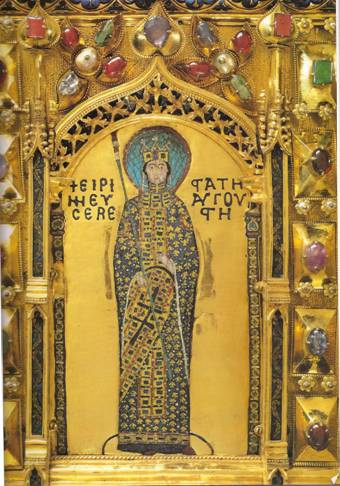 |
I MILLE ANNI DELL’IMPERO BIZANTINO TRA INTRIGHI COMPLOTTI E COLPI DI STATO MICHELE DUCAS-PUGLIA |
L’imperatrice Irene moglie di Alessio I Particolare della Pala d’Oro-Venezia S. Marco |
CAP. VIII
L’EPOCA DEI COMNENO
PARTE PRIMA
SOMMARIO: LE ORIGINI E I PRETESI ASCENDENTI E DISCENDENTI; L’EROTICO CAPOSTIPITE STORICO DEI COMNENO; ISACCO E ALESSIO OCCUPANO COSTANTINOPOLI; ALESSIO INCORONATO DISTRIBUISCE CARICHE E RICCHEZZE-COLPO DI MANO DEL FIGLIO GIOVANNI PER LA SUCCESSSIONE; IL TERRITORIO DELL’IMPERO E LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITO (In nota: I Peceneghi o Pazinaci); ALESSIO ORGANIZZA LO STATO (In nota: La storia si ripete, spaccato dell’Italia di oggi e l’oro degli italiani comparso); LA PRONOIA E IL FEUDALESIMO BIZANTINO; ARRIVANO I NORMANNI: ROBERTO GUISCARDO E BOEMONDO (In nota Il Guiscardo, col racconto di Mescabele, Sichelgaita e Boemondo nella descrizione di Anna Comnena); LA BATTAGLIA NEL MARE E NELLA PIANA DI DURAZZO; LE QUESTIONI POLITICHE SI INTRECCIANO CON QUELLE RELIGIOSE; GIOVANNI ITALO - NILO E BLACHERNITE-PAULICIANI E BOGOMILI-I MANICHEI E LA STRAGE DEI PECENEGHI; PARTONO LE BANDE DEI PELLEGRINI AVANGUARDIA DELLA PRIMA CROCIATA: GUALTIERO SENZA-AVERI-PIETRO L’EREMITA-GOTSHALK-IL CONTE EMICONE MASSACRATORE DI GIUDEI (In nota L’odio nei confronti degli ebrei); I CAVALIERI SI RIUNISCONO ALLE PORTE DI COSTANTINOPOLI; I CAVALIERI TRASPORTATI SULL’ALTRA SPONDA DEL BOSFORO SI APPROPRIANO DI ANTIOCHIA CON L’AUSILIO DELLA SACRA LANCIA E DI EDESSA E TRIPOLI (In nota: I ponti sul Bosforo e il tunnel e il ponte sullo stretto di Messina); LA TRAGICA CONQUISTA DI GERUSALEMME.
LE ORIGINI
E I PRETESI ASCENDENTI
E DISCENDENTI
|
E |
stinta la dinastia macedone, dopo una serie di imperatori, usurpatori e incapaci (v. Imperatori del periodo di mezzo Cap.VII/3), un’altra dinastia si affaccia al governo dell’impero; appartenente alla casta “militare”, essa vantava origini antiche e man mano che diventava più potente le origini venivano riportate sempre più indietro nel tempo: il capostipite avrebbe fatto parte del seguito dell’imperatore Costantino quando si era trasferito a Bisanzio (329), con il quale sarebbero stati imparentati, prendendo in Grecia un nome che sarebbe derivato dalla città di Komné (in prossimità di Adrianopoli), dove inizialmente si erano stabiliti.
In seguito i poco affidabili genealogisti man mano che la famiglia diventava più potente, esaltarono ulteriormente le origini, collegandole non solo agli imperatori romani, ma alla gens Silvia, Julia, Flavia …. fino a risalire al figlio postumo di Enea e Lavinia, Giulio Silvio .... superando anche Enea, per finire al mitico Teucero re della Troade (2500 a. C.)!
Andando più concretamente alla famiglia imperiale si erano formati due rami; estinto il principale, rimaneva il collaterale di Trebisonda, nominalmente “imperiale” (sebbene si trattasse di un impero ridotto alla sola città di Trebisonda e dintorni!) i cui discendenti, con una discutibile genealogia, si sarebbero propagati in Italia, Savoia, Corsica e Francia (v. nota al par. Michele VII Ducas del capitolo precedente e in Articoli: La nascita della nobiltà”).
A parte le grandi famiglie dalle note ascendenze, la storia dell’umanità è sempre stata piena di presunti discendenti che avendo altre origini, in un bel momento si appropriavano di ascendenze dettate dalla propria fantasia e dalla propria megalomania creandosi così una nuova personalità e un nuovo stato: si pensi a Luigi XVII figlio Luigi XVI, la cui morte era ben documentata, ma erano emersi ugualmente ben sette truffatori che sostenevano di essere il figli di Lugi XVI e di Maria Antonietta!
Tra i tanti esempi vi è anche quello celebre di tempi più recenti (anni sessanta) di Anna Anderson di cui abbiamo parlato nella Genealogia dei Romanov (v. in Sez. Genealogie, v. anche Altavilla) che aveva commosso il mondo facendo apparire i Romanov degli avidi opportunisti che disconoscevano una loro parente per appropriarsi della sua eredità; ma il DNA, aveva finalmente (dopo decine di anni!) fatto giustizia, riconoscendo che la Anderson era completamente estranea ai Romanov che (morta nel frattempo, 1985), aveva montato una vera e propria impostura!
E, tra i Romanov, non era stato l’unico caso! Era infatti emerso un preteso discendente della granduchessa Maria (sorella di Anastasia) che si faceva passare per Altezza Reale (e viveva alla grande, con le elargizioni che arrivavano da tutto il mondo, da parte di sostenitori!) il quale sosteneva che a Ekaterineburg (1918) la granduchessa Maria si fosse salvata e aveva sposato un sedicente principe d’Angiò (anch’egli altro discendente unico sopravvissuto da una battaglia!), di cui questo auto-proclamato Altezza Reale sarebbe stato pronipote, il quale aveva scritto un libro (1989) in cui erano state inserite foto di documenti del tutto inconsistenti!
Altrettanto può dirsi dei numerosi Comneno che si dichiarano diretti discendenti della famiglia imperiale (che imparentata con le altre famiglie imperiali ne hanno accomunato e assunto tutti gli imperiali cognomi, riportati, come abbiamo visto, sulla tomba di Totò!).
Ma, questa dei discendenti degli imperatori bizantini non è l’unica storia, in quanto di discendenti di antiche famiglie reali storicamente estinte, ma improvvisamente risorte a distanza di secoli, che creano fantasiosi ordini cavallereschi e concedono titoli e onorificenze, non mancano; ciò che meraviglia è che costoro riescono a crearsi una tale credibilità, da avere anche numeroso seguito che li sostiene (come succedeva al “Doktor Faust” v. in Articoli)!
Per vincere questo scetticismo che possa dirimere ogni dubbio, attualmente la scienza ce ne offre gli strumenti con l’esame del DNA, divenuto peraltro di semplice fattibilità: basterebbe sottoporsi a questo esame per ottenere una certificazione di autenticità che eliminerebbe tanti dubbi fatti sorgere da documenti di altrettanto dubbia autenticità (vi è una curiosità a proposito di ricerche sul DNA: si stanno ricercando i discendenti di Gengis-Kan, che sembra ve ne siano alcune migliaia sparsi per il mondo!).
Nel corso dei secoli XVIII e XIX vi è stato un proliferare di testi sui Comneno, scritti per la maggior parte dai diretti interessati, che si ritenevano di discendenza imperiale (***); uno di essi trovandosi in Francia durante il regno di Luigi XVI, era riuscito ad ottenere il riconoscimento (con regie patenti del 1782 e 1784), di “filiazione imperiale” da Davide Comneno ultimo “imperatore” di Trebisonda!
Mentre gli storici affermavano che tutta la famiglia di quest’ultimo imperatore era stata trucidata (1463) da Maometto II (e sui massacri da parte dei turchi specie quando si volevano evitare rivendicazioni postume, si poteva giurare!), dopo ben oltre trecento anni (1782-1784) emergeva un capitano della reale cavalleria francese, che aveva tutt’altro nome e cognome (come capita sempre in questi casi!), quello di Demetrio Stephanopulos, il quale a questo suo cognome aveva aggiunto quello di Costantino Comneno, sostenendo che dal massacro di Maometto II si era salvato uno dei figli dell’imperatore Davide, Niceforo, di cui egli era il legittimo discendente!
Relativamente a questo evento erano state prospettate due ipotesi; una che il giovanissimo Niceforo era stato fatto prigioniero e educato dai turchi (erano i ragazzi che convertiti all’Islam, finivano nel corpo dei giannizzeri) e l’altra, che Niceforo si sarebbe rifugiato prima in Persia, poi era finito tra i monti del Peloponneso a Mania, dove sarebbe divenuto capo di quella comunità.
Successivamente da uno dei pretesi discendenti di Niceforo, che si sarebbero trasferiti in Italia e in Savoia per sfuggire ai turchi (!), dopo essersi recato in Corsica (1676), all’epoca sotto il dominio di Genova, quando la Corsica era passata sotto il dominio della Francia, emergeva questo capitano di cavalleria dell’esercito francese, Demetrio Stephanopulos, alias Costantino Comneno, il quale, dichiarandosi diretto discendente da Davide Comneno, richiedeva al re le indicate lettere patenti accordate, confermate dal Parlamento e registrate alla Corte dei Conti.
Per avere questo riconoscimento, il capitano Stefanopulo, aveva presentato una documentazione (nel libro si indicano i documenti forniti***), ma si trattava di documentazione nebulosa in quanto non originale perché tutta di riferimento (una parte scritta in greco, altra rilasciata dalla Repubblica di Genova, ma si trattava di autentiche di copie di copie, atti di notorietà, insomma, nessun documento originale (!), con l’albero genealogico ... redatto dallo stesso funzionario della Cancelleria reale, proprio il responsabile che doveva rilasciare le patenti ...come si vanta lo stesso autore!); dopo questo iter del tutto superficiale, la domanda era stata accolta e Demetrio Stephanopulos, alias Costantino Comneno, era riconosciuto con quest’ultimo nome e cognome con “titolo principesco e di filiazione imperiale”!
*) Nel libro “Le glorie cadute (del ramo principale) dell’antichissima e augustissima famiglia Comnena” dell’Abate Lorenzo Miniati (scritta in elogio del confratello Vincenzo Comneno, dell’Accademia degli Oziosi di Napoli, Venezia,1663); seguito da altri testi tra i quali “Coup d’oeil historique et genealogique sur l’origine de la maison imperiale des Comnenes” par le Chevalier d’Henin; e ancora: “Coup d’oeil de la maison imperiale Comnéne et se vicissitudes” par le prince Démétrius Comnéne, Londres, 1815), e “Précis historique de la maison imperiales des Comnénee” (pubblicato anonimo ad Amsterdam, 1784); e ancora: Lettre de Demetrius Comnéne à M. Koch Membre du Tribunat, “Auteur de l’Ouvrage intitulé Tableau des Revolutions de l’Europe. Sur l’eclarissement d’un point d’histoire relatif à la fin tragique de Davide Comnéne, dernier Empereur de Trebisonde, Precédée et suivie d’une Notice historique sur la Maison imperiale des Comnéne (Paris 1807); e “Sur la Grèce”, par le prince Georges Comnéne (Paris, 1807).
A proposito del riferimento fatto al libro scritto dallo storico M. Koch è da dire che in “Tableau des Rivolutions de l’Europe” in tre volumi, citando Calcondila, Koch aveva scritto che la famiglia di David Comneno (l’ultimo imperatore di Trebisonda) era stata interamente massacrata da Maometto II; contro questa affermazione era insorto Demetrio Comneno che aveva scritto a Koch la propria tesi secondo la quale il figlio Niceforo era stato l’unico a salvarsi, sebbene fosse finito prigioniero dei turchi ed educato all’islam (e divenuto certamente un terribile giannizzero, come tutti i ragazzi cristiani convertiti!); Koch, senza mostrare di voler approfondire la questione, gli rispose semplicemente che “le sue considerazioni poteva pubblicarle” (ma né negava la propria versione, né confermava l’altra!) e Demetrio Comneno aveva quindi scritto la sua versione di fatti dal trasferimento in Corsica (1676!) alle lettere patenti del re (come detto, fondate su documenti non autentici), comunque ottenute, attestavano che il capitano di cavalleria Stephanopulos, proveniva dalla famiglia imperiale di Davide Comneno.
**) Nel Capitolo VII (Prima Parte) abbiamo parlato del libro reso bellamente antico da Fozio che aveva ricostruito la genealogia dell’imperatore Basilio I, che vale come esempio di tutte le falsificazioni di libri e documenti della storia!
***) Tra le altre singolarità riscontrate, ve n’è una più particolare: il libro usato per la nostra ricerca, intitolato “Lettera di Demetrio Comneno” (a M. Kock, Editeur Rondonneau,1807) porta in ogni pagina annotazioni scritte a penna, completamente cancellate a inchiostro, in modo che non si possano leggere; queste cancellature fanno sorgere il dubbio di annotazioni contrarie al contenuto del testo e deliberatamente cancellate; oltretutto, come abbiamo rilevato la Cancelleria araldica reale (la corruzione di funzionari serpeggiava anche a quel tempo!), non solo aveva preso per buona tutta la documentazione fornita dallo Stephanopulos, ma era stato lo stesso funzionario della Cancelleria, specificamente delegato all’araldica, che gli aveva redatto l’albero genealogico ... era stato con questi presupposti lo Stefanopulo otteneva ufficialmente il riconoscimento sia del nome di Costantino Comneno, sia della discendenza dall’imperatore di Trebisonda!
L’EROTICO
CAPOSTIPITE STORICO
DEI COMNENO
|
P |
assando ai Comneno storici, gli unici di cui si ha notizia sono stati il Niceforo che abbiamo trovato nella cospirazione contro Costantino VII, (precedente Cap.), e un Manuele detto “l’ Erotico” emerso durante il regno di Basilio II Bulgaroctono (958-1025), il quale viveva in una casa modesta, si era nobilitato sposando una esponente della famiglia Ducas di livello molto più elevato, gratificato dall’imperatore con una benefica elargizione di una rilevante proprietà terriera in Paflagonia.
“L’Erotico” ebbe due figli, Isacco e Giovanni i quali avevano probabilmente ereditato una tal forza genetica prolifica, da dar luogo a numerosa figliolanza che costituiva la base dei nuovi componenti della famiglia, i quali combinavano matrimoni con famiglie potenti, acquisendo volta per volta sempre più potere.
Si giunse così al primo imperatore, Isacco I (1057-1059), che farà la fortuna di tutta la famiglia, poi seguito dagli altri tre di cui parleremo più avanti; la loro durata supererà appena un secolo ma il loro nome sarà tanto enfatizzato da dar l’impressione che i Comneno avessero regnato per secoli.
Il ramo di Alessio I si estingueva con Manuele I (1180) il cui figlio Alessio veniva eliminato dall’infelice nipote Andronico (della sua vita romanzesca parleremo in un prossimo capitolo), mentre il ramo cadetto (di Trebisonda), si estingueva ufficialmente dopo circa trecento anni (1463) in quanto tutta la famiglia era stata trucidata, come abbiamo detto, da Maometto II.
Sempre stando alla realtà storica, come abbiamo visto nel precedente capitolo, Isacco I, non aveva avuto figli, mentre il fratello Giovanni dalla moglie Anna Dalassena, ne aveva avuti otto.
Costei, era figlia di uno dei più alti funzionari d’Italia e, sebbene di lei si sappia poco, si può dedurre che fosse una donna dalla tempra eccezionale (vera matrona romana), che aveva la consapevolezza del rango (sono le madri spesso a determinare la fortuna o sfortuna dei figli!), e aveva saputo allevare e ben indirizzare gli otto figli da dar loro educazione e istruzione adeguata che li aveva portati ad occupare posti di rilievo.
Di questi figli, cinque erano maschi: Manuele, Isacco, Alessio, Adriano e Niceforo e tre femmine, Maria, Eudocia, e Teodora (che sposerà Costantino figlio dell’imperatore Romano Diogene v. Cap. VII/3).
Isacco I, come abbiamo visto, intendeva cedere la corona al fratello Giovanni, ma Giovanni non volle accettarla, per cui la scelta del successore cadeva su Michele VII Ducas detto “Parapinace” (come indicato nel Cap. VII/3 durante il periodo di calamità aveva ridotto a tre quarti la misura di vendita del grano mantenendo il prezzo dei quattro quarti, ma anche per le confische e le rapine che rovinavano intere famiglie), imperatore che sebbene avesse avuto per precettore il grande Michele Psello (v. Cap. VII/3), oltretutto esperto nei maneggi e intrighi di Corte, invece di farne un uomo di Stato, lo aveva indirizzato “alle ricerche minuziose, etimologiche e grammaticali, alla retorica e filosofia” senza insegnargli l’arte di governare” e invece di farne uno statista capace di governare un impero, ne aveva fatto un topo di biblioteca!
E così Michele VII Parapinace non avendo le giuste doti necessarie per governare ... era stato estromesso al primo colpo di stato dai suoi stessi generali che avevano scatenato una guerra civile e gli avevano usurpato il trono rinchiudendolo in un convento (più avanti vedremo un falso Michele, che nonostante il vero fosse ancora vivo, si presentava da Roberto Guiscardo per essere messo sul trono)!
Tra questi generali (come già si è detto), aveva preso il potere Niceforo III Botaniate (1078-1081), il quale per avere un riconoscimento di regalità e un legame con la precedente dinastia, aveva sposato l’imperatrice Maria l’Alana (proveniente dall’Alania-Armenia in quanto figlia del re Bagrut IV,), moglie di Michele VII, nonostante il marito fosse ancora in vita (dedicatosi alla vita ecclesiastica era vescovo di Efeso); Maria era bella di spirito e di corpo, bionda con carnagione scura con gli occhi di uno sparviero circondati da sopracciglia ben delineate, erano come un gioiello incastonato nell’oro, “adorna di eleganti forme diffuse da parte a parte in tutte le sue membra e in tutte le parti del corpo da non rinvenirsene a quei tempi altra idonea a competere con lei in bellezza” (A. C.).
Questo matrimonio, aveva suscitato uno scandalo presso il clero, sia perché come detto Michele VII era ancora in vita (e ciò per il clero costituiva un vero e proprio adulterio), sia perché Niceforo era al suo terzo matrimonio (al quale il clero bizantino, come abbiamo detto in altra occasione, era decisamente contrario).
Intanto a palazzo, sebbene i due Comneno fossero ben visti da Niceforo il quale aveva affidato ad Alessio il comando di tutto l’esercito nominandolo gran domestico e i soldati amavano questo giovane generale, da parte dei ministri dell’imperatore si stava organizzando un complotto nei confronti dei due fratelli, in quanto si riteneva fossero divenuti troppo potenti e mettevano in pericolo il loro potere.
ISACCO E ALESSIO
OCCUPANO COSTANTINOPOLI
|
Q |
uesto che esamineremo è un altro dei periodi importanti della storia di Bisanzio che si incrocia con quella dell’Occidente attraverso le Crociate le quali, da guerra di liberazione del Santo Sepolcro per i famelici feudatari occidentali, erano diventate guerre di conquista che avevano finito per travolgere lo stesso impero bizantino, portandolo, nel tempo, alla sua estinzione
I due fratelli si trovavano a Costantinopoli e avvertiti nel mezzo della notte (1081) si recavano alle Blacherne dov’erano le scuderie imperiali e presi i cavalli di cui avevano bisogno, fuggono dopo aver tagliato i garretti a tutti gli altri cavalli, per impedire di essere inseguiti.
Dopo aver raccolto l’esercito (a Tchorlu o Tzuroli ai confini della Tracia), ritornano a Costantinopoli; per entrare in città, Alessio sapeva che sarebbe stato difficile forzare le mura, per cui conduce trattative con il capo della guardia tedesca (Gilpracte) della porta Charisios che non opporrà alcuna resistenza; il giovedì della settimana di Pasqua i soldati dei Comneno superate le mura senza trovare resistenza, vanno ad aprire le porte della prima cerchia; superate anche le seconde mura, prive di difesa, dopo aver aperto le porte, fanno entrare in città il resto dell’esercito.
I soldati tra i quali si trovavano traci, macedoni, greci e altri barbari, una volta entrati in città, si danno al saccheggio, “le vergini consacrate a Dio furono stuprate, le dame violentate, i templi spogliati dei loro ornamenti, non furono risparmiati i calici sacri, i cibori, i santi buttati per terra; i senatori che stavano cercando di mettersi in salvo furono fatti scendere dai muli e dopo averli depredati furono lasciati andare a casa a piedi”.
Alessio era padrone della città; il prefetto Radeno recatosi da Botaniate che dal Sacro Palazzo si era rifugiato in Santa Sofia, lo convince a recarsi al monastero del Periblepton dove, vinte le sue resistenze, indossa il saio: finiscono così i suoi sei anni e sei mesi di un regno turbolento, travagliato dalla guerra civile.
Alessio per dare ufficialità alla corona che stava per prendere, aveva dovuto prendere accordi con l’imperatrice Maria Alana, rifugiata in convento col piccolo Costantino Ducas (avuto da Michele VII) per farsi adottare; Maria chiede che gli accordi vengano messi per iscritto e in cambio della adozione ottiene la associazione (già in precedenza fatta dal padre) di Costantino al regno (1081), impegno poi non mantenuto come vedremo tra breve.
Giorgio Paleologo raggiunge la flotta ancorata nel porto e raccoglie tutti i marinai e soldati portandoli sotto le mura per acclamare con gran fracasso (per tutta la notte) Alessio e Irene Augusto e Augusta
Poiché il clero imputava ad Alessio il saccheggio, i sacrilegi e le profanazioni commesse dai suoi soldati quando erano entrati in città, prima di incoronarlo, gli chiese di chiedere pubblicamente perdono e assoggettarsi alla penitenza di quaranta giorni di digiuno.
Alessio inoltre, per la presa di Costantinopoli aveva avuto un valido aiuto del cesare Giovanni Ducas che, appoggiato dalla sua potente famiglia avrebbe potuto facilmente prendere il potere; Alessio era vedovo della prima moglie (figlia di Argiro) e sebbene le sue simpatie fossero rivolte verso la sua protettrice Maria Alana, per volere della madre Anna Dalassena dovette sposare la nipote di Giovanni (figlia orfana di Andronico Ducas), Irene, che per la sua forte personalità a Costantinopoli era designata come “la madre dei Comneno”.
 |
ALESSIO INCORONATO DISTRIBUISCE CARICHE E RICCHEZZE COLPO DI MANO DEL FIGLIO GIOVANNI PER LA SUCCESSIONE |
| Alessio I Miniatura |
|
A |
lessio si faceva incoronare da solo come Alessio I (1081-1118) all’età di trentatré anni e presa la corona pensò bene di elevare il livello dei suoi familiari assegnando nuove cariche di cui egli stesso aveva inventato i titoli; iniziava dalla madre (che aveva fatto uscire da un convento dov’era rifugiata), alla quale diede il titolo di “imperatrice”; ma vi furono le rimostranze dei familiari di Irene, che non era stata incoronata, per cui Alessio corse ai ripari facendola incoronata dopo sette giorni, prendendo il titolo di augusta.
La seconda carica dopo l’imperatore era assegnata al fratello Isacco, nominato “sebastocrator” (*), che fungeva da “vice-imperatore”; al cognato Michele Taronite, che aveva che aveva sposato la sorella, assegnò la carica di “protosébaste”(con le varianti di protosebastiaros, hypersebaste”); dei due fratelli, Adriano ebbe la carica di “protosébaste” e Niceforo (generale della flotta) quella di “gran drungario e sebaste”; a Niceforo Melisseno che aveva preso le armi contro Botaniate fu assegnata la carica di “cesare” unitamente alla città di Tessalonica, dove doveva andare ad abitare, con rendite degne di così alta fortuna (Alessio poneva così le basi di un clan familiare che manterrà il potere per poco più di un secolo: 1081-1185).
Alle cariche, pur essendo le finanze dell’impero senza risorse, aggiunse le ricchezze elargendo a parenti e affini (racconta Zonara) “carretti pieni di ricchezze pubbliche, rifornendoli anche di grano perché fossero serviti magnificamente, non come persone private, ma alla maniera dei grandi imperatori e volle che avessero anche grandi ville e palazzi in proprietà, uguali, per la loro magnificenza, a quelli abitati dai re”; ma non si comportò alla stessa maniera, con i senatori che svilì e non onorò nel modo che si conveniva ma piuttosto deprimerli e abbassarli e con i nobili con i quali non si mostrò benigno, ciò, aggiunge lo storico non permette di considerare il Comneno, imperatore perfetto in quanto non osservò in tutto la regola della giustizia che consente che sia dato a ciascuno ciò che merita: “di questo imperatore”, conclude Zonara, “non dirò altro, per non intaccare il suo onore”.
Per distribuire queste ricchezze Alessio fece ricorso ai beni dei conventi (dove i laici erano nominati per dirigerli, come già prima di lui aveva disposto l’imperatore Isacco) che dipendevano direttamente dalla metropoli, dove giungevano i loro benefici che l’imperatore attribuì ai “caristicari” (così detti i beneficiari), dai quali costoro ricavavano enormi rendite, tanto che la Chiesa metropolitana si trovava in difficoltà per pagare tali imposte (la maggior parte delle donazioni era fatta dai vescovi dai quali gli imperatori rimanevano estranei); ma con Alessio tutto cambia in quanto era l’imperatore ad assegnare e distribuire i beni dei conventi.
Per fare un esempio, tra i familiari beneficiari dei beni espropriati, al fratello Adriano, erano state donate le rendite della penisola di Kassandra (tra il golfo di Kassandra e il golfo di Salonicco) che comprendevano tutti i suoi redditi e questi redditi provenivano dall’imposta fondiaria pagata dai dipendenti alla Chiesa; la concessione imperiale accordava ad Adriano il diritto di far riscuotere questo canone direttamente dai propri esattori; i monaci ritennero che pagando a un laico, essi sarebbero divenuti semplici paroikoi (v. sotto), vale a dire di non essere più proprietari (enfiteutici) ma solo coloni che occupavano un terreno altrui e che in seguito potevano essere sottoposti a ulteriori rendite; essi reclamarono presso l’imperatore, il quale li rassicurò che pagando il canone al fratello, sarebbero rimasti loro i proprietari.
Quanto al giovane Costantino Ducas (incoronato dal padre**) che indossava gli stivaletti di porpora, Alessio (come scrive Zonaras) glieli aveva fatti requisire perché il comando dell'impero spettava solo a lui, ma la madre Maria riuscì a ottenere una bolla che gli riconosceva il rango di “cesare” e gli accordava il diritto di indossare gli stivaletti imperiali e nelle acclamazioni di essere nominato dopo di lui (Costantino morirà giovane); dopo di che Maria si ritirò nel palazzo dei Mangani (complesso costituito da palazzo, convento, chiesa e ospedale), di sua proprietà, in quanto a lei donato dal secondo marito Niceforo Botaniate, con il contiguo monastero.
Alessio era di piccola taglia, dal corpo assai grosso, “aveva un’espressione di duro temperamento, con spesse sopracciglia e uno sguardo dolce e penetrante”; la figlia Anna (kaiserissa), sempre compiacente con suo padre, aveva scritto che “a vederlo in piedi mancava di prestanza, ma quando era seduto sul trono mostrava tutto il suo prestigio” (lei stessa comunque era bruna, piccola e somigliava al padre).
Egli si riteneva investito di una missione divina e sembrava nato per regnare, avendo il talento e le grandi qualità di un monarca; di carattere fermo e di spirito generoso, fine e astuto, non si esaltava per i successi e non si abbatteva per le avversità; nonostante durante tutto il suo regno avesse dovuto far fronte alle guerre aveva ricostituito ciò che rimaneva della parte costiera del vecchio impero e aveva avuto cura delle lettere, delle arti e delle leggi, oltre alla propensione al lusso sfrenato che aveva introdotto a Corte.
Da Irene aveva avuto tre figli maschi, Giovanni, Isacco (tra loro alleati) e Andronico (che parteggiava per Anna) e quattro femmine, Anna che era la primogenita (dopo la morte di Costantino Ducas a cui era stata promessa (**), aveva sposato Niceforo Briennio) e Maria, Eudocia e Teodora (di altri due figli, Manuele e Zoe non si hanno notizie probabilmente perché morti nell’infanzia... e magari i genealogisti li avrebbero fatti anche rinascere! v. sopra).
I circa trentasette anni e mezzo di regno di Alessio I erano stati dedicati per la massima parte alle guerre, non solo con i propri confinanti, ma perché aveva dovuto affrontare i nuovi nemici normanni giunti dall’altra parte del mare Adriatico, che intendevano impadronirsi dell’impero e sebbene non vi fossero riusciti, avevano provocato migliaia di morti e la distruzione del territorio.
Nonostante le sue lunghe assenze a causa delle guerre, a Corte si viveva in uno sfarzo che aveva abbacinato gli occhi dei crociati latini, suscitando la loro avidità; essi infatti, non appena se ne presenterà l’occasione, si impossesseranno di parte del suo territorio, prima con i feudi e poi con l’impero latino (1204).
Avvicinandosi al termine della vita, Alessio agonizzante, veniva portato nel monastero dei Mangani; il figlio Giovanni, sapendo che la madre lo aborriva e nella successione al padre appoggiava la sorella Anna (e quindi il marito Niceforo), si era organizzato in modo che ciò non avvenisse, riferendo le sue intenzioni ai parenti più stretti e in particolare al fratello Isacco; di nascosto dalla madre, era poi entrato nella camera dove giaceva Alessio e inginocchiatosi come per pregare, gli sfila di nascosto l’anello imperiale e radunati i suoi sostenitori, salito a cavallo, si reca al Sacro palazzo acclamato imperatore dai suoi sostenitori.
Giunto a palazzo, le guardie pur avendo visto l’anello, volevano avere qualche altra prova, al che Giovanni fece ricorso alla forza, facendo scardinare la porta di bronzo, che, dopo essere entrato con i suoi, fece subito richiudere; la madre Irene ai Mangani, accortasi di quanto stava succedendo, aveva mandato a chiamare il figlio, ma inutilmente in quanto Giovanni non si era presentato, per cui inviperita, si rivolge a Niceforo Briennio (che non aveva troppa predisposizione a diventare imperatore, come si vedrà più avanti), per fargli compiere il colpo di Stato; quando si rese conto di questa impossibilità, si recò dal marito che respirava appena e gettandosi su di lui (racconta divertito Coniata!), “versando lacrime come una fonte scura, inveì urlando contro il figlio, che mentre lui era ancora vivo, lo spogliava del regno; ma il marito non rispondeva volgendo gli occhi al cielo; l’imperatrice inveiva ancora più infuriata e Alessio alzando le mani al cielo, forse perché si rallegrava a sentire quelle notizie che gli erano gradite, oppure perché la moglie pensava al potere mentre la sua anima si staccava dal corpo, o pregava Dio per le sue mancanze”; ma la moglie, credendo che il marito godesse, ritenendosi tradita nelle sue aspettative, gli disse:- Marito mio, da vivo ti distinguevi per ogni sorta di menzogne, eri un campione nel dire il contrario di quello che pensavi e anche ora che stai per andartene non sei diverso da come eri prima”.
Durante la loro vita matrimoniale, mentre Alessio propendeva per il figlio maggiore Giovanni, Irene era molto legata alla figlia Anna e non faceva che calunniare Giovanni definendolo precipitoso, dalla condotta di vita effeminata, instabile e per niente buono, mentre onorava il genero Briennio con ogni sorta di lodi, dicendo che aveva una istruzione liberale e costumi equilibrati che costituivano la base per l’esercizio del potere da parte di un governante; Alessio, consapevole dell’affetto materno, alle volte simulava di essere preso da affari urgenti o fingeva di non badare alle sue parole o assicurava che avrebbe tenuto conto dei suoi suggerimenti; a volte infine la riprendeva dicendole di smetterla di voler rompere l’armonia della famiglia oppure la mandava a farsi benedire o ancora portava l’esempio degli imperatori romani tra i quali non si era mai verificato che un imperatore avesse privilegiato il genero al posto del figlio, aggiungendo: “tutto il popolo riderebbe alle mie spalle e penserebbe che sono uscito di senno”; altre volte la prendeva in giro dicendo che stava riflettendo: era infatti, prosegue Coniata, “simulatore quant’altri mai, considerava sempre cosa saggia l’arte del raggiro e generalmente non si mostrava loquace sul da farsi”.
*) I titoli accordati ai principi di sangue reale erano 1. despota, 2. sebastocrator, 3. caesar, 4. panhypersebastos e 5. protosebastos e Anna Comnena era estasiata dalla diversa gradazione di questi titoli che erano vuoti ma soddisfacevano la vanità e solleticavano l’ambizione dei cortigiani; Gibbon fa riferimento alla felice flessibilità' della lingua greca che permetteva di unire i nomi di augusto, sébastos e imperatore autocrator (e questa unione produsse assurdità come pan-yper-sébastos, tutto-sopra-augusto ....per dire augustissimo!) e quindi sebastocrator, ecc. (v. in Schede: Cerimoniale e cariche alla corte di Bisanzio)
**) Nei ricordi di Anna (che aveva sette anni e Costantino diciassette), dice di lui: “mi è dato rammentarlo non senza effusione di abbondanti lacrime, era stato modellato dalla natura come un campione di bellezza, candida qual latte la pelle, cosparsa bellamente di vivace rosseggiamento simile al rosa nel primo spuntare dalla boccia; gli occhi non bianchi ma da sparviero scintillanti [...] tramandanti fulgori di gemme [...] fattezzze celestiali superiori a ogni terrena concezione [...] tanto rifulgeva in lui l’attraente forza di un’assolutissima bellezza e a mirarle ispirava amore”.
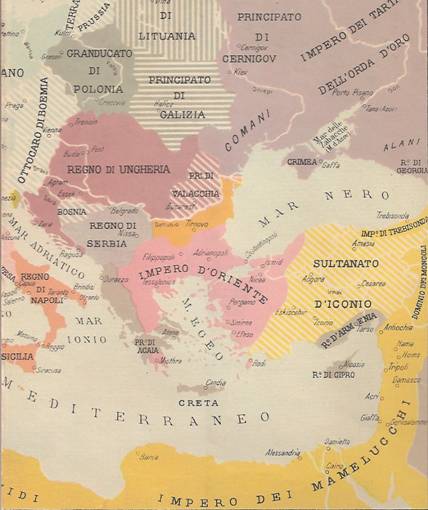
L’impero durante il regno di Alessio I
IL TERRITORIO
DELL’IMPERO
E LA RIORGANIZZAZIONE
DELL’ESERCITO
|
L |
’impero bizantino ereditato da Alessio, come si vede dalla pianta, non era più quello di Giustiniano o di Basilio II Bulgaroctono (v. pianta in Cap. VII P. II) ma ridotto alla metà; per questo ci sembra esagerata l’eccessiva esaltazione data al secolo dominato dai Comneno, sebbene avessero ben governato; in questo contesto era emersa la figura di Alessio, il primo della dinastia, che pur avendo potuto regnare per un periodo piuttosto lungo, era stato, suo malgrado, quasi tutto dedicato alle guerre, di difesa piuttosto che di espansione o conquista; e questo regno (così ridotto!) si continuava a considerarlo enfaticamente “impero”, come sarà considerato quello di Nicea e l’ultimo rimanente, di Trebisonda!
L’Impero si trovava anche in una situazione di grande miseria e di decadimento e pur contenuto in tali ristretti confini, questi erano continuamente attaccati da tutte le parti: a sud infatti, eroso dai turchi discendenti dei selgiuchidi (che avevano sostituito il sultanato di ar-Rhum o di Iconio, in cui ai califfi era riconosciuta la sola autorità religiosa), i quali (*) avevano unito all’autorità religiosa anche quella politica (che sarà la rovina dell’islam!); a nord la penisola balcanica era occupata dai peceneghi (**) e alle frontiere occidentali vi erano la Serbia e la Croazia che avevano approfittato della decadenza dell’impero per rompere tutti i legami con Bisanzio e ciascuna aveva un proprio monarca; in Croazia infatti regnava Zvonimir, incoronato a Spalato da due emissari del papa (1076); e nel sud della Serbia (in parte conquistata dal Bulgaroctono), Stefano Bodin che dopo una insurrezione (1071) era stato estromesso, si era alleato con Alessio al fine di recuperare il regno, ma alla prima occasione (come vedremo prima della battaglia con Roberto Guiscardo) si ritirò; infine Alessio dovette far fronte all’arrivo dei normanni prima e barcamenarsi con i crociati dopo.
Alessio cercherà di recuperare i territori perduti (assicurandosi solo Nicea, Smirne, Efeso e Sardi) estendendo la costa sud del Mar Nero, e poi si troverà a dover affrontare una invasione del tutto nuova, che per la prima volta proveniva dall’Adriatico, quella dei normanni, con Roberto Guiscardo e il figlio Boemondo le cui intenzioni (come vedremo) erano quelle della conquista Costantinopoli.
Da buon generale Alessio si dedica alla organizzazione dell’esercito, al momento sparuto e disorganizzato, mentre nel frattempo l’impero aveva perso la potenza della flotta e il dominio del mare finito nelle mani dei veneziani, e, nei limiti delle sue possibilità, era riuscito a ricostituirla, (1087), non solo per affrontare la spedizione contro i peceneghi, ma per fare servizio di polizia nell’arcipelago e in seguito, sorvegliare i crociati.
L’armata bizantina era formata per una parte da contingenti greci e dall'altra da truppe ausiliarie di cui era completamente sfornita; i contingenti greci erano formati da soldati che provenivano dai themi al cui obbligo i potenti latifondisti si sottraevano, ma Alessio dopo aver controllato le liste di chi doveva fornirli, se li fece assegnare; il resto dell’armata era servita da truppa ausiliaria di russi, vareghi (o varanghi o waringhi, dei quali Malaterra dice che erano angli), colningi, turchi, alani, inglesi, franchi alemanni, bulgari, ma era limitata; essa comprendeva anche la guardia imperiale formata da varanghi, immorteli, ikanati, bestiariti e arcontopuli (quest’ultimo corpo era stato creato da Alessio, formato dai figli di soldati nobili morti).
Avendo così riorganizzato l’esercito ne prese il comando assoluto seguendo personalmente le operazioni militari in modo che i generali ora giocavano un ruolo secondario, nel senso che non avevano alcuna autonomia decisionale ma dovevano prendere gli ordini da lui.
Avendo Alessio preso personalmente il comando e conoscendo l’arte militare, si era impegnato personalmente ad addestrare (“con perseveranza” scrive A. C.) i soldati, ai quali insegnava a maneggiare le briglie del cavallo, a tirare le frecce, a esercitarsi a tendere imboscate e a un comando a riunirsi in falange; poiché era noto che i cavalieri francesi, quando erano a cavallo, non vi era nessuna forza che potesse resistere al loro impeto, ma quando erano a piedi la pesantezza delle loro armi li rendeva del tutto inermi, aveva suggerito ai suoi arcieri di colpire i cavalli anziché i cavalieri.
Non solo, ma aveva osservato che l’esercito turco non combatteva unito come tutti gli altri eserciti ma era diviso in tre parti con un centro e due ali, separate da grandi spazi ai quali si aggiungeva un corpo di riserva collocato in retroguardia, che si teneva molto lontano dai corpi di battaglia; quando uno di questi era attaccato, gli altri accorrevano nei fianchi per circondare l’armata nemica che colpivano con le loro frecce; se incontravano resistenza, fuggivano rapidamente ma sempre in buon ordine e quando vedevano il nemico sparpagliato per inseguirli, si rivoltavano e li attaccavano frontalmente e singolarmente; nelle loro manovre erano assecondati dai meravigliosi cavalli arabi o tatari che erano di una agilità e docilità estrema e formidabili nella fuga e nel combattimento; la bravura di quei cavalieri che non usavano lance ma frecce (che bucavano anche le armature) lanciate con tanta precisione da andare sempre a segno colpendo il cavallo o il cavaliere.
Alessio quindi aveva istruito i soldati per queste evenienze e per di più aveva trovato anche una nuova tecnica descritta in maniera non molto tecnica da Anna (che si profonde in elogi per il padre!), intesa in questo modo: i turchi avevano la spalla destra scoperta per tirare le frecce e il resto del corpo coperto dallo scudo; Alessio aveva quindi insegnato ai soldati di non tirare le frecce direttamente in avanti, come d’uso, ma obliquamente verso la sinistra in modo da colpire la parte scoperta del cavaliere che era a sinistra di quello che si trovavano di fronte.
*) I possedimenti turchi al momento dell’insediamento di Alessio erano Cesarea di Cappadocia, Iconio, Filadelfia, Smirne, Sebaste e Neo-Cesarea mentre ai greci rimanevano, nella parte settentrionale Eraclea del Ponto, una parte della Cappadocia, la Paflagonia e Trebisonda.
**) I PECENEGHI o PAZINACI
Era una popolazione della stessa razza dei turchi, stabilita dopo il IX sec. nel territorio della Valacchia e nelle pianure della Russia meridionale che si estendevano dalle rive del Danubio alle rive del Don; occuparono il thema di Cherson che costituiva il territorio più avanzato del possedimenti bizantini sul mar Nero; fungevano da commissionari commerciali con tutti i territori più interni (Russia, Kazaria ecc.) per cui Costantino Porfirogenito aveva suggerito al figlio di mantenere con loro rapporti amichevoli.
Un capovolgimento dei rapporti avvenne con la conquista da parte dell’impero, della Bulgaria in quanto i peceneghi costituivano un centro di equilibrio con tutti i popoli confinanti mantenendo la pace con i vicini, russi e ungheresi, ma la conquista della Bulgaria orientale da parte di Giovanni Zimisce portò le truppe greche ai bordi del Danubio e i peceneghi si trovarono quindi in diretto contatto con le truppe greche e bastava attraversare il Danubio per trovarsi in territorio greco; ciò avvenne con Costantino Monomaco quando una parte di peceneghi (per divisioni intestine) chiese asilo all’imperatore il quale concesse tre fortezze sui bordi del Danubio con l’incarico di assicurare la sicurezza delle frontiere.
Con le continue guerre contro i barbari il territorio occupato dai peceneghi si ingrandiva continuamente ma la popolazione rimaneva barbara e il governo bizantino, con l’imperatore Costantino Monomaco, pensò di civilizzarli, cominciando ad arruolarli nel proprio esercito; ma le continue infiltrazioni di peceneghi provenienti dalla Russia meridionale capovolse l’idea civilizzatrice bizantina.
La scheda ad essi dedicata (*), seguendo la Cronaca di Nestore, termina con il loro ritiro in Bulgaria (1054), dove si sarebbero amalgamati con i bulgari, in quanto per dieci anni le fonti non parlano di loro; essi invece in quei dieci anni avevano avuto la possibilità di aumentare di numero e prendere poco a poco coscienza della loro forza; divenendo sempre più audaci, penetravano poco per volta verso l’interno, fino a occupare il territorio tra i Balcani e il Danubio da dove facevano incursioni nel cuore dell’impero: invasero infatti la Tracia e la Macedonia (1064); Bisanzio per tenerli buoni offriva loro un tributo che Michele VII (1071-1078) ritenne autonomamente di diminuire, ma una rivolta lo costrinse a cambiare idea; essi non erano neanche affidabili in quanto, nella sfortunata campagna contro i turchi di Romano Diogene, un corpo di peceneghi prima della battaglia tradì l’imperatore passando dalla parte di costoro.
Divenuti più forti nel periodo della lotta tra i competitori del trono (1078-1081) che, combattendosi tra di loro li invogliavano alle razzie dell’impero, ed essi, passando dall’uno all’altro, si legavano a chi li pagava meglio; nel periodo di Botaniate attraversarono diverse volte i Balcani e Alessio Comneno andò a combatterli con le sue truppe.
Quando Alessio prese il potere l’impero aveva perduto tutte le conquiste di Zimisce nella Bulgaria orientale in quanto i peceneghi si erano impadroniti della catena dei pendii dei Balcani al nord fin verso il Danubio, mentre dopo le stragi compiute dal Bulgaroctono e i privilegi concessi alla Chiesa e alla nobiltà, la Bulgaria si univa all’impero e da parte greca vi era stato un tentativo di ellenizzazione con la divisione del territorio bulgaro in themi, con tutti i funzionari che essi comportavano (duchi, strateghi, ricevitori d’imposta ecc.) ma lo spirito bulgaro libero, vivace e indipendente riuscì a rimanerne indenne; mentre Alessio si libererà alla fine dei peceneghi con la sua astuzia (v. sotto).
*) In Schede S. “I peceneghi e l’impero di Bisanzio secondo la Cronaca di Nestore”
L’ ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO
|
A |
bbiamo visto come Alessio avesse assunto il potere sull’esercito ad evitare che gli ufficiali gli si potessero rivoltare contro; tutti i suoi predecessori infatti, avevano lasciato ampio spazio ai generali che gestivano direttamente le campagne militari; Alessio invece si era messo egli stesso a capo delle truppe e dell’esercito e tutte le cariche più importanti le aveva affidate a membri della sua famiglia, in modo che i generali potessero giocare solo un ruolo secondario, venendo così loro tolto ogni spirito di cospirazione da cui spesso erano presi, come si era verificato proprio con lui!
Per poter avere nelle sue mani anche il potere politico aveva innanzitutto privato il Senato (formato dai maggiorenti dell’impero) di poteri; poiché la nuova organizzazione alla quale si stava dedicando, comportava anche enormi spese e le casse dello Stato erano state completamente svuotate dai suoi predecessori (come abbiamo visto nei precedenti capitoli), Alessio aveva perseguito in maniera implacabile tutti gli abusi, aveva requisito i beni degli appartenenti al Senato e dei ricchi e potenti, comportandosi con equità nei confronti del popolo (*), e, nello stesso tempo requisiva tutti i beni della Chiesa, immobili e mobili: questi ultimi tutti oggetti preziosi presi anche in occasione della guerra con i normanni, in seguito pagati per le proteste suscitate dal clero e dal popolo.
Infatti, poiché la popolazione della capitale, sobillata dal clero, se ne lamentava, Alessio per far cessare le lamentele riunì alle Blacherne il Senato, i capi militari e il clero e dopo essersi giustificato delle necessità che lo avevano condotto a tali misure (portando come esempi precedenti Pericle e Davide), fissò una somma in argento da prelevare dalle imposte annuali e da versare alla Chiesa.
Non bisogna dimenticare che le ricchezze dei monasteri (come già abbiamo avuto modo di rilevare nei precedenti capitoli), erano a dir poco "immense"; per fare qualche esempio, il podere di Pisson collegato al monastero di Lavra aveva una estensione di cinquemila ettari; i poderi dei monasteri della regione dell’Athos, come il monastero di Chilandari, era di millecinquecento settanta ettari; quello di Esfigmenu era undicimilacentocinquanta ettari e quello di Xeropotamu di minor dimensioni ...sempre rispettabili, era di cinquecentosettanta e di Zografu, trecentosettantacinque ettari.
Vi è da aggiungere che alla fine dell’XImo secolo i monasteri erano in decadenza sotto tutti i punti di vista, particolarmente della morale; in proposito, per darne un esempio è riportato (fonte originaria: Giovanni d’Antiochia, tra l’altro anatemizzato con la setta dei nestoriani alla quale apparteneva, v. in Schede S, “Scismi e riti nella Chiesa orientale”), quanto accadeva nei conventi dell’Athos, dove un gruppo di valacchi si era stabilito su quelle terre, coltivandole e rifornendo ai monasteri (dove era severamente proibito l’ingresso alle donne) i vari i prodotti del loro lavoro; le loro donne vestivano come gli uomini e avevano il compito di guardare le greggi e di portare ai conventi i prodotti quali latte, formaggio e lana; le cose però andarono oltre in quanto i monaci si erano resi conto di cosa si nascondeva sotto gli abiti maschili (e per la verità non facevano neanche, come si dirà tra breve, troppa distinzione tra donne e uomini!) e questo aveva svegliato i loro famelici appetiti sessuali... “e le cose andarono tanto oltre” dice il cronista ... il quale però ci priva di un racconto boccaccesco, il quale si limita a dire “che sarebbe vergognoso riferirle” e la faccenda non riguardò solo le donne valacche ... ma più tardi scoppiò un altro scandalo, causato dalla presenza di ragazzi e giovani imberbi!
Vi è anche da aggiungere che i monaci annoiati della vita monastica, uscivano o per qualche ufficio o per visitare parenti e amici e vagando per le strade si dirigevano a Costantinopoli; essi inoltre rifiutarono di sottomettersi alle decisioni di Cristodoulos (poi santificato), che aveva cercato di moralizzare la situazione; intervenne quindi Alessio che, con una “novella”, chiedeva al patriarca di metter fine a questa situazione, successivamente minacciando i monaci che si recavano alla capitale senza l’autorizzazione dei superiori, di far loro tagliare il naso.
Tornando ai beni della Chiesa e dei conventi, essi erano sottoposti al regime fiscale della imposta fondiaria, ma vi erano numerose eccezioni e la Chiesa finiva per godere dell'esenzione relativamente a quanto riscuoteva dai paroikoi e dai klerikoi, che erano i diretti coltivatori e versavano le imposte alla Chiesa, la quale però non ne dava conto allo Stato.
Alessio volle quindi conoscere esattamente i redditi di questi beni e fece fare un severo censimento; ciò' provocò la reazione del clero che riteneva insopportabile che fosse conosciuto lo stato dei propri redditi; Alessio emise quindi ancora una “novella” con cui stabiliva il canone da versare che era di gran lunga superiore a quello previsto dalla precedente (emessa dell'imperatore Isacco), sopprimendo, tra l’altro, le esenzioni di cui godevano gli ecclesiastici quando passavano da una diocesi all'altra.
Alessio aveva anche pensato di rendere redditizie le condanne penali sostituendo le condanne a morte con la più remunerativa confisca dei beni; quanto al tesoro pubblico (come abbiamo visto) precedentemente dilapidato, il nuovo imperatore abolì i regali che di solito imperatori e imperatrici facevano a magistrati e a tutti i personaggi eccellenti.
Tra le misure fiscali prese da Alessio, poiché si verificava che gli esattori, nella tassa proporzionale riscuotevano più di quello che poi versavano, fissò in dettaglio la quota della contribuzione, intervenendo poi sulla qualità delle monete.
A questo proposito poiché gli introiti non bastavano, egli fece ricorso alla manipolazione della moneta, il nomisma d’oro, che i suoi predecessori avevano alterato riducendo la quantità di oro in esso contenuto; egli fece fondere la nuova moneta miliarisia in bronzo (che valeva meno), della quale si serviva per i pagamenti che doveva effettuare, mentre i pagamenti che doveva ricevere li pretendeva in oro o in parte in oro e in parte in bronzo (avendo bisogno di bronzo prelevò gli oboli dalle chiese e fece abbattere alcune statue di bronzo per ottenere monete e nel contempo aumentò le decime), la qual cosa portò a una certa confusione in quanto gli esattori valutavano da sei a dodici volte ciò che era dovuto in nomisma.
L’imperatore al quale giunsero le lamentele fece fondere dei miliarision d’argento in modo che il valore del nomisma equivaleva a quattro miliarision, ma questa misura era stata male accolta, per cui Alessio fece fare una nuova moneta di bronzo di piccolo taglio equivalente a 1/48 e 1/12 del nomisma (che finì per essere scambiato con quattro delle piccole monete, miliarisia) ma nella pratica si verificava che per un nomisma si incassavano tre miliarisia!
*) LA STORIA SI RIPETE:
SPACCATO DELL’ITALIA DI OGGI E L’ORO DEGLI ITALIANI SCOMPARSO
|
L |
a Storia spesso, sebbene sotto altre forme, si ripete, e come diciamo ogni tanto, quando introduciamo argomenti di attualità (come p. es. in Bizantinismo e Burocratismo, sez. Schede S.), vediamo che situazioni simili a quelle di Alessio, relativamente alla mancanza di fondi pubblici, si riproducono al nostro presente; che cosa si può dire dell’Italia di oggi? Che è un Paese allo sbando e in stato di indigenza; completamente bloccato nella sua economia, sia nella produzione sia nella mancanza di posti di lavoro che sta facendo aumentare la povertà (secondo statistiche internazionali il 20% detiene l’80% della ricchezza l’altro 20% lo detiene l’80% che paga le tasse!); diminuiscono finanche le nascite a causa delle insopportabili spese da parte delle giovani coppie che devono provvedere al loro mantenimento, ma anche perché essi non vedono alcuna prospettiva per il loro futuro!
Al presente infatti il 44% dei giovani (2milioni!) è senza lavoro mentre altri (centomila) vanno a lavorare all’estero (una curiosità statistica dimostra quanto il nostro Paese sia anomalo: su sessanta mln. di abitanti, vi sono 40mln. idonei al lavoro ... ma di questi, lavorano solo 23mln. gli altri 17mln. dovrebbero essere i pensionati che invece ufficialmente sono 18.1mln. (2016), con l’evidente differenza di 1,1mln che potrebbero essere i falsi pensionati!).
Il Paese è in forte stato di arretratezza e senza risorse, sebbene i principali esponenti di Governo continuino a mandare messaggi di incoraggiamento, annunciando che l’economia è in ripresa (dello 0,%!), indirizzandosi a cittadini rassegnati che hanno perso la speranza di una spinta rigeneratrice che potrebbe venire solo da un piano di sviluppo in cui si prevedano lavori pubblici, ricerca e nuove tecnologie, queste ultime (in cui l’Italia ha delle eccellenze), ancora trascurate, lasciano aperte le porte per la fuga di cervelli.
Senza una chiara visione del futuro, signigfica togliere ogni speranza alle nuove generazioni e purtroppo tutti i governi che continuano (e continueranno) ad avvicendarsi tirano solo a campare e vanno avanti tappando i buchi che si presentano giorno per giorno.
Le riforme poi è meglio dimenticarsele, perché o vengono fuori aborti (come le Province) o corporazioni e burocrazie che si sono trovate i loro spazi e non le consentono: “hic manebimus optime” qui rimaniamo ottimamente ... e non le scardinerà nessuno; quanto al referendum che doveva confermare quelle varate, la interpretazione del voto contrario dato dagli italiani non va inteso nel senso che le riforme le hanno volute, ma nel senso che hanno voluto mandare a casa (a furor di popolo, col 70% di partecipanti al voto mai visto in Italia!) un Presidente che non aveva operato bene e del referendum ne aveva fatto una questione personale, tanto da aver dichiarato che se perdeva se ne sarebbe andato ... e così è stato accontentato!
Con rammarico non possiamo che constatare che i tre governi (c.d. non eletti) che si sono succeduti (prima del quarto), avevano suscitato vane speranze ... ignorando completamente i due principi basilari di una buona democrazia, (che proprio la sinistra che li sosteneva, avrebbe dovuto tener presente), vale a dire “equità e giustizia sociale”, interamente stravolti, in quanto, invece di prestare una mano ai deboli (non certamente con l’assegnazione degli 80 €. o dei 500 €. agli studenti, inutile regalo paternalistico di sapore elettorale), si erano salvaguardati in tutti i modi i nababbi delle caste, i privilegi e poteri forti (ricordate i 4mld. tolti dalle bocche degli italiani e donati a MPS.? Ora si scopre che a questa banca ne servirebbero altri 8mld. .... mentre i crediti non riscossi sono 17mld!); tutto questo danaro elargito alle banche in crisi finisce in un pozzo di san Patrizio, che non serve a tutelare i risparmiatori ... e certamente non basteranno i 20mld. stanziati dal Governo entro cinque anni per salvarle: provate a indovinare a spese di chi!
E si evita testardamente di intervenire sugli sprechi, intendiamo quelli veri individuati da Carlo Cottarelli (l’argomento è stato approfondito in Articoli: Il Corpus juris civilis, L’abbaglio ecc., al par. Italia), non quelli che arricchiscono i vari e famelici funzionari tra i quali serpeggia la corruzione come vediamo ogni giorno, quando ne viene arrestato qualcuno!
In proposito è da dire che la criminalità nell’arco di una ventina di anni ha fatto un salto di qualità, infatti mentre prima proveniva dal popolo, ora proviene dalla classe che una volta era definita borghesia (che aveva ben altre qualità morali) di professionisti, docenti universitari, magistrati, alti funzionari della P. A. e alti ufficiali!
Il quarto governo (definito governo fotocopia), sta facendo quel che può, ma solo per risolvere i problemi quotidiani, con l’assillo di tutti i rappresentati di spezzoni di partiti che quotidianamente non fanno che chiedere nuove elezioni ... a tutti i costi, anche senza una legge elettorale, idonea a lasciar lavorare un governo per tutti e cinque gli anni di mandato, perché l’interesse che li spinge, non è il bene del Paese, ma quello evidente della distribuzione di poltrone; per come è messa l’Italia occorrono decine di anni di impegno e preparazione per creare qualche milione di posti di lavoro (il migliaio di assunzioni non è che una goccia nel mare!) per poterla risollevare e certamente per ottenere questo intento occorrono non solo governi stabili ma che anche nel loro alternarsi abbiano unicità di intenti!
Questo stato di cose è aggravato dalla evasione fiscale, che ha raggiunto livelli altissimi quanto insopportabili (da 180/200mld.), che non si riesce a estirpare perché si usano sistemi blandi e non si applica la vecchia legge “manette agli evasori” (sebbene non abolita!) ... sembrerebbe ... per una sottesa benevolenza di carattere elettorale; se infatti per gli evasori fosse previsto l’arresto immediato (come avviene negli USA), questa oscenità che sposta tutto il peso della fiscalità dello Stato sulle classi meno agiate (le tasse in Italia sono giunte a livelli insopportabili), essa cesserebbe immediatamente (l’annuncio che nel 2016 sono stati recuperati - teoricamente - 18mld. non conforta, in quanto siamo ad appena al 10% del totale, con una valanga di ricorsi che rendono effimero il recupero!).
E’ da aggiungere che l’esorbitante debito pubblico dello Stato è aggravato dalle continue emergenze naturali ai quali è sottoposto il nostro fragile Paese, tra terremoti e inondazioni, i cui maggiori danni sono dovuti allo scriteriato saccheggio del territorio operato in tanti anni dalle amministrazioni locali, assolutamente impreparate anche ad apprestare i primi soccorsi, come si è visto nelle zone terremotate, aggravati dai ritardi dovuti allo scaricabarile burocratico della P.A. ... redarguito anche dal papa Francesco (ritardi che si sono riversati anche sulle casette che sebbene pronte non sono state consegnate!).
Chiudiamo questo non breve sfogo, ritornando ad Alessio I; come abbiamo visto, l’imperatore aveva fatto ricorso ai tesori della Chiesa e certamente non vogliamo che si arrivi a questo, ma a proposito di oro, vogliamo ricordare che ai tempi del Governatore della Banca d’Italia Guido Carli (1960-75), si parlava del “tesoro degli italiani” in lingotti d’oro dal valore svariati miliardi (anche in €.!), conservato in quei “caveau”, sui quali da anni è calato un “sepolcrale silenzio” (anche da parte della stampa!) e non solo nessuno ne parla ma pare che anche una interrogazione parlamentare sia rimasta senza risposta; e allora chiediamo:- Che fine ha fatto quel tesoro? Perché prima lo si faceva vedere con orgoglio, con foto, ed ora non se ne sa più niente? E’ stato rubato? E’sparito? Si era vociferato che una parte costituisca garanzia per la U.E. ... ma solo una parte ... e tutto il resto dov’è finito? E chi può controllare l’operato della inattaccabile Banca d’Italia (che dovrebbe pur essa essere ridimensionata, in quanto le funzioni principali sono state assorbite dalla BCE. e le sedi in tutte le province costituiscono solo spreco di danaro pubblico)?
LA PRONOIA E
IL FEUDALESIMO
BIZANTINO
|
A |
bbiamo visto nel cap. precedente (VII P. II), come le assegnazioni fatte dagli imperatori e le usurpazioni delle ricche famiglie avevano portato alla costituzione delle grandi estensioni dei latifondi (che avevano dato agli storici occidentali la possibilità di parlare di feudalesimo il cui termine era ignorato dai bizantini, come già detto (Cap. VII P. II) citando Zacariæ von Ligenthal*), che non comportavano alcun obbligo da parte dei proprietari ad eccezione di ciò che riusciva ad ottenere il fisco.
Con Alessio incomincia a svilupparsi una forma di feudalesimo che non aveva i connotati di quello occidentale (che sarà invece introdotto con l’avvento dei “latini-francesi” dei fiefs, in greco fia, e terminerà con la fine del loro regno) ma prettamente bizantino, con la riproposizione della “pronoia”.
Questa costituiva una evoluzione rispetto alle precedenti concessioni agli “stratioti” (v. Cap. V par. Eraclio e la riforma dello Stato e Cap. VI) in quanto in questo caso le terre erano concesse direttamente ai contadini-militari, mentre i “pronoikoi” erano i ricchi-potenti ... così potenti e prepotenti, come abbiamo anche visto, che, non dovendo dar conto a nessuno (specie quando vi erano imperatori deboli), si appropriavano dei terreni altrui, fossero anche quelli della Chiesa!
Si trattava di assegnazione di terre a questi ultimi (pronoitari) come ricompensa per servizi resi e in cambio del versamento di una rendita o della prestazione militare in caso di chiamata; essa inizialmente era limitata di norma fino alla morte dell’assegnatario, ma poi divenne ereditaria ...
e la prestazione militare era finita per non essere più eseguita!
Ma Alessio nella riorganizzazione dell’esercito, passando in rassegna le liste dei militari che usufruivano delle concessioni e non mandavano i soldati, le regolarizza facendosi assegnare il numero dei militari dovuto.
A proposito delle proprietà avute in concessione, vi erano i contadini (paroikikón) che provvedevano alla coltivazione versando al “pronoitario” (il quale in pratica fungeva da esattore), le rendite e le imposte; egli poi, da quanto riscuoteva (scaricando sui primi ogni sorta di tributi e di corvées), versava le quote delle imposte dovute allo Stato e il resto lo tratteneva per sé.
Successivamente al nomos georgikòs (v. in Schede Storia), con l’imperatore Teofilo (834) per designare gli agricoltori proprietari si usò il termine “paroikoi” e i basilici avevano utilizzato spesso il termine “paroikoi” al posto del latino “coloni” (termine usato anche in Giustiniano), ma quello attuale (del periodo di Alessio) era stato adottato per indicare il grande proprietario terriero mentre la maggior parte dei nuovi insediamenti nelle grandi proprietà si era potuta fare attraverso i “paroikikón”, mentre “paroikoi” costituiva il termine universalmente adottato per designare il grande proprietario terriero.
*) La conquista dei francesi in Oriente aveva trapiantato in questo paese lo stabilimento e l'istituzione dei feudi (fia), con tutti i suoi caratteri (fissati nelle Assise di Gerusalemme), ma il genio orientale non si prestò all'idea della fede feudale reciproca e ereditaria; l'istituzione del feudo non aveva potuto mettere radici profonde. I piccoli despoti non avevano nessuna concezione dell'dea del vassallaggio; esso scomparve con la caduta della dominazione latina non senza aver lasciato qualche traccia del suo passaggio, perché proprio al principio feudale “nessuna terra senza signore” fu attribuita questa circostanza della quale in seguito non si farà più menzione di beni rurali indipendenti (in Zachariæ, Droit privé greco-romain, 2 voll. Paris 1869).
ARRIVANO
I NORMANNI
ROBERTO GUISCARDO
E BOEMONDO
|
L |
a conquista della Puglia e della Calabria tolte all’impero bizantino, non quietarono le ambizioni di Roberto il Guiscardo (1025 c.a-1085) ... che si estesero al resto dell’impero, al di là del mare Adriatico!
Il Guiscardo (*) aveva sposato in prime nozze Alberada di Buonalbergo che gli aveva dato un figlio, Marco detto Boemondo (*) e tre femmine, Emma, Olimpia e Heria; ma egli avendo sotto di sé vassalli longobardi aveva necessità di consolidare con loro i suoi rapporti e all’epoca l’unico modo per stringere vincoli di carattere politico era il matrimonio.
Roberto facendo annullare dal papa (“per consanguineità”!) il matrimonio con Alberada, sposava la sorella di Gisulfo (figlio del principe longobardo di Salerno Guaimaro, potente e di alto lignaggio, dopo che Roberto aveva conquistato la città), Sichelgaita (Sigelgaita), per cui Boemondo e le sorelle diventavano figli bastardi, ma il padre considerava Boemondo il suo braccio destro, il quale in occasione delle crociate con il nipote Tancredi (figlio di Emma) andrà a conquistare il principato di Antiochia (1099-1111) e costituirà la dinastia di Antiochia.
Da Sichelgaita Roberto aveva avuto due figli maschi, Ruggero detto Borsa per la mania di contare e ricontare le monete (il quale erediterà il titolo di duca di Puglia e Calabria e principe di Salerno) e Guido (duca di Amalfi) e tre femmine, Matilde, Sibilla e Mabilia (tutte ben sposate),
Roberto aveva condotto trattative con l’imperatore bizantino Michele VII e per confermarle veniva proposto il matrimonio del fratello di Michele, Costantino, con una delle sue giovanissime figlie (v. Cap. precedente); Roberto rifiutava il matrimonio con l’anziano fratello dell’imperatore, per cui il matrimonio veniva concordato con il figlio, Costantino Ducas (nato nel 1074) e a Costantinopoli fu inviata la figlia Olimpia.
Il periodo a Costantinopoli era turbolento in quanto era in corso un colpo di Stato da parte di Niceforo Botaniate (v. Cap. precedente), per cui appena giunta la fanciulla (1075 o 1076), da parte dell’usurpatore Botaniate le fu dato il nome di Elena e relegata nel gineceo (il matrimonio con Costantino non ebbe luogo, come invece alcuni ritengono; Malaterra è tra costoro per di più egli scrive che Costantino era stato evirato per non fargli fare figli con una normanna!); Anna Comnena confermerà che la figlia del Guiscardo era stata promessa a Costantino e successivamente a lei, ma era morto (è stato detto, combattendo) anzitempo, e lei sposava Niceforo Briennio; il Guiscardo ne fu risentito e decise di vendicarsi.
Nel frattempo gli si presentava (1078) un monaco sotto le vesti dell’imperatore Michele che riferiva di essere stato detronizzato ed era fuggito dal monastero dove era stato relegato, sostenendo di essere padre di Costantino che aveva sposato la figlia, (v. precedente Cap., nella nota al par. di Michele VII Parapinace, ma era una falsità in quanto il matrimonio non aveva avuto luogo!), e gli chiedeva aiuto per riconquistare il trono perduto.
Si trattava di un impostore chiamato Rettore (probabilmente un monaco o un domestico del palazzo imperiale), che, aveva frequentato la Corte e aveva conosciuto il vero imperatore; Roberto per sua convenienza finge di credergli e gli riserva grandi onori, abbracciando la sua causa e, rivestendolo della porpora, lo circondò di una corte, tenendolo presso di sé fino alla partenza per Durazzo (1081).
Durante i preparativi Roberto pensò di mandare a Costantinopoli un suo ufficiale, conte Raoul, per portare le sue lamentele a Botaniate e annunciargli il suo arrivo, ma Raoul, giunto in Grecia gli scrive dicendogli che il suo imperatore era un impostore, che egli stesso aveva visto quello vero nel monastero, che Botaniate non regnava più e che il suo successore era Alessio I che avrebbe dato la porpora al giovane Costantino e che la figlia promessa sposa era trattata bene e la progettata guerra sarebbe stata ingiusta; Roberto si infuriò e non volle intendere queste verità, mostrandosi risentito con Raoul il quale, temendo una vendetta, andò a cercare rifugio a Costantinopoli presso l’imperatore.
Con l’assenso del papa, che detestava il patriarca di Costantinopoli e appoggiava questa causa, fu concesso a Roberto lo stendardo di san Pietro; nel frattempo Roberto, allestito l’esercito e la flotta si preparava a partire (il tratto di mare da percorrere da Brindisi a Durazzo, di cento miglia, era designato come “passaggio romano” sul quale sia Pirro, sia Pompeo, avevano avuto la stravagante idea di costruirvi un ponte!).
Accompagnato da Sichelgaita e dal falso imperatore, duchi e conti italiani e longobardi e avventurieri francesi che si erano uniti a lui, trecento cavalieri costituivano il nerbo normanno, trentamila soldati e cinquanta navi fornite da Ragusa trasportavano soldati, cavalli armi, macchinari da assedio e torri ricoperte di pece; Roberto aveva assegnato a Boemondo quindici navi in modo che lo precedesse aspettandolo a Corfù (che aveva fortificazioni che la rendevano imprendibile, ma all’arrivo di Boemondo non fu opposta alcuna resistenza).
Roberto lo raggiunse a Corfù e mentre Boemondo si diresse a Durazzo con le sue truppe via terra, Guiscardo vi si recò via mare, ma presso la lingua di Acrocemonia al capo di Glossa, sebbene la stagione fosse favorevole e la flotta navigava lungo la costa, un forte uragano misto a neve distrusse la flotta spazzando via vele, alberi e remi e riempiendo il mare e le rive di pezzi di vascelli, di armi e di cadaveri; il mare inghiottì gran parte delle munizioni e la galera ducale a malapena riuscì a sfuggire al furore della tempesta; Roberto si fermò una settimana per raccogliere il resto della flotta assegnata a Boemondo.
Alessio, non avendo una propria flotta per far fronte a quella normanna, aveva chiesto l’aiuto a Venezia che gli fece sottoscrivere un trattato (1082) a duro prezzo; esso prevedeva per Domenico Silvio o Selvo (che aveva sposato una principessa bizantina) per la prima volta il riconoscimento del titolo di “doge” (anche per la Dalmazia e Croazia: “Dux Venetiarum, Croatiae et Dalmatiae”) nonché (per sé e i suoi successori) il titolo di protosebastos (pincipe augusto), oltre a un rilevante onorario annuo; inoltre, per quel che più conta, fu concesso ai veneziani la libertà di commercio in tutto l’impero, con esenzione del pagamento dl dazio per tutte le merci che arrivavano da Venezia, e tutto ciò a scapito del commercio bizantino; per di più gli amalfitani divennero tributari dei veneziani e inoltre ottennero magazzini in Costantinopoli e tre moli di transito a Galata: fu con questi presupposti che ebbe inizio la potenza marinara di Venezia (inutilmente l’imperatore Giovanni II, successore di Alessio, cercherà di modificare questo trattato (1126), ma Venezia si oppose occupando le isole bizantine dell’Egeo e Giovanni fu costretto a firmare altro trattato che ratificava il precedente!).
*) ROBERTO IL GUISCARDO - MESCABELE - SICHELGAITA E BOEMONDO NELLA DESCRIZIONE DI ANNA COMNENA (*).
ROBERTO IL GUISCARDO - MESCABELE E SICHELGAITA
Racconta Anna (nata nel 1083 dopo l’arrivo di Roberto a Durazzo 1081) che Roberto fu di patria normanna, di bassi natali (secondo Malaterra Tancredi era un guerriero e signore di Hauteville e aveva avuto due mogli di riconosciuta nobiltà, anche se di piccola nobiltà, non poteva essere di bassi natali, come scrive A. nda.), d'indole tirannica, d'animo astutissimo (ebbe come nutrice furberia e malizia d’ogni fatta”), da ciò il sopranome di Guiscardo, forte di braccio, rimirante con avido sguardo le ricchezze e le felicità degli ottimati, d'insuperabile violenza e d'invincibile fermezza nel seguire i suoi desideri, ostinandosi a realizzarli. Era di così elevata statura da non aver confronto tra gli altissimi chi lo uguagliasse; la sua pelle tendeva al rosso, la chioma al biondo; larghi avea gli omeri e gli occhi tanto vivi da sembrare scintillanti; nelle membra era di giuste proporzioni ... l'avresti detto lavorato al tornio dalla natura con certo qual artifizio, da renderlo ben piantato dalla pianta dei piedi alla sommità del capo, siccome ricordo avere udito da molti suoi conoscenti che lo avevano visto, che per nulla avresti potuto trovare il più piccolo difetto e doverlo considerare quasi un ideale. Quanto alla voce, come Omero aveva detto di Achille, aveva una voce tumultuante e i suoi urli (come ci era stato riferito), avrebbero atterrito e messo in fuga miriadi di persone. Dotato di cotanti pregi dalla natura, dalla fortuna e dall'indole dell'animo, era geloso della propria libertà e alieno dall’assoggettarsi a chiunque o dal prestare servile omaggio, carattere, dicono, delle grandi menti. Essendogli venuto a noia vivere sottomesso ad altri, abbandona il luogo natale, la Normandia, con cinque cavalieri e trenta pedoni al tutto e va con essi ad occupare le foreste e le spelonche intorno ai disviati monti lombardi (della Puglia, come già spiegato) ove, posti a ruba i viandanti provvide se stesso e i suoi di cavalli, pecunia ed armi: questo fu l’inizio del suo vivere di stragi e di sangue umano.
A questo punto Anna introduce un personaggio, sconosciuto ai cronisti e storici al quale dedica ben tre paragrafi del suo Lib. I (indicato nella versione greca come Γελίελμες-Gelielmes quindi Geglielmo e riportato sia da Giuseppe Rossi nella sua traduzione italiana (Milano. 1846), sia in quella francese di Cousin (Paris, 1672), come Guillome Mescabele-Guglielmo Mescabele, suocero di Roberto, al quale aveva dato in moglie la figlia con una sostanziosa dote che costituiva la prima proprietà di Roberto.
Ora sappiamo che la prima moglie di Roberto era Alberada di Buonalbergo, figlia del signore normanno di Buonalbergo, ma di questo Mescabele, come abbiamo detto non vi sono riscontri né da parte di cronisti, né da parte di storici.
Anna parla anche di Sichelgaita, seconda moglie di Roberto, sempre al suo fianco, anche i guerra; descritta di grande corporatura e dotata di grande forza fisica, vestiva un “saio”, la veste militare usata dai romani di lana grossa e pelosa, corta fino alle natiche e sotto aveva una “stola”, abito lungo fino a terra proprio delle donne romane; in battaglia quando indossava l’armatura con la lunga chioma che le usciva dall’elmo, era spaventosa a vedersi, come novella Walchiria della quale Anna dice che “aveva fama di essere terribile in guerra, dalla narrazione di alcuni autori, era una Pallade, se non una Minerva; osservati i fuggenti (battaglia di Durazzo, v. sotto), usando la patria favella e non l’Omerico detto: fino a quando fuggirete, arrestatevi e siate prodi guerrieri; né ciò bastando con una lunga asta, con alte grida tien dietro minaccevole ai codardi i quali dopo averla osservata, con scambievoli esortazioni, furono animati a compiere il loro dovere”
*) Ci siamo limitati solo a qualche piccolo intervento filologico per non guastare la bellezza dell’impianto linguistico; su Anna Comnena e l’Alessiade v. Scheda Storia.
E BOEMONDO
Anna nonostante odiasse i latini, sentimento nutrito dal padre e da tutti i greci, pur nella sua giovanissima età di tredici anni (in cui era già intellettualmente matura*) dopo aver sentito i racconti delle imprese di Boemondo (e di quelle del padre di cui lei scrive “che era somigliantissimo”), quando lo aveva visto a Corte, fosse andata anche oltre nella sua ammirazione vedendolo come un ideale di guerriero, se ne fosse innamorata o come diciamo noi moderni avesse preso per lui “una cotta”!) aveva descritto: “Baimundo “imberbe” (nel senso che come la maggior parte dei normanni radeva la barba, mentre i veneziani l’avevano lunga come i bizantini), per dirla breve [...] alla sua grandissima nomea, a un'ammirabile presenza ingannatrice degli occhi, cercherò alla meglio di indicarne forme e sembianze.
Assai elevata erane la taglia, superando poco men d'un cubito (il cubito in Grecia - Erodoto - corrispondeva a un avambraccio quindi circa 54 cm. nda.) gli altissimi dell' umana schiatta; larghe le spalle, ampio e piano il torace, muscolose le braccia, ventre e fianchi ristretti; tutto l'insieme del corpo non magro, non pingue per ridondanza di carne, ma tenendo giusto mezzo in tra lo scarno della persona ed il pieno, quasi modello ed opera d'un Policleto, trattone il tipo dalla più, sublime arte. Avea mani e piedi grandi anzi che no, e ben forniti di vitali umori; gli ultimi acconciamente disposti a tracciare vigoroso passo; omeri e collo abbondanti di succo e dignità.
L' imbusto, in ogni sua parte esaminato, parea un minimo che divergente dalla perpendicolare, non già colpa delle vertebre o della spina dorsale, ma contrattone, come appariva, a significanza di modestia, così dai precettori ammaestrato infin dalla verdissima età sua. Bianca oltre modo erane la carnagione [...] infra il candor della neve rosseggiavagli il volto, e biondeggianti capelli sol dilungavansi a coprirgli le orecchie, né, seguendo il patrio costume, ingombravan la schiena, ben alieno dall' impazzare a mo' de' folli premurosissimi di nutricar la chioma. Qual poi fosse il color della barba non mi è dato indicarlo, poiché guance e mento, rasi infimo alla rute, mostravan la superficie loro più levigati di qualsivoglia marmo; volendo tuttavia congetturarvi sopra, l'avrei detta rubiconda. L'occhio ceruleo e minaccevole non bene nascondeva qualche mescolanza di barbarie e sdegno; libero spiravagli il naso da piuttosto larghi meati [...] per ricevere a bell'agio e tramandare l' aria spintavi dal vasto polmone a refrigerio del ferventissimo cuore [...]. Traluceva, lo confesso, in tutta la presenza un che di giocondo, se quel mite raggio non fosse dalle frequenti folgori di terrore offuscato, da ogni lato prorompenti .
Vinte dunque le poche sue amabili prerogative da maggior copia di altre suscitanti verso
lui odio, la gigantesca figura
e alcunché dì severità nella elevata sua
fronte [...] quasi minaccia di
cimentar lor forze, traspariva, al guardarlo
da capo ai piedi, una mescolanza inesplicabile di
fierezza e tristezza, donde il suo ridere mi
appariva più ameno e gradevole di chi abbia un aspetto sdegnoso, quantunque fossero manifesti il genio marziale e
ogni gradevole indignazione [...] tutta la
sua piacevolezza s'appalesava opera della naturale forma corporea e il truce orgoglioso vigore parto del barbaro animo che albergava in lui;
era questo, non solo ricolmo di
malignità, ma intiernemente capace di tutti
gli artifizi idonei a recargli profitto; nessuno più di lui sagace, nessuno più pronto ad escogitare
mezzi opportuni ad ogni varianza de'
tempi; giammai poteva cogliersi sproveduto
non mancandogli scudo a difesa di qualunque
assalto (verbale ndr.); accurato erane il discorso nel ragionare,
e le sue risposte, munitissime di circospezione
e prudenza, non temeano l' occhio della più severa censura, o d'esser colte in fallo.
Egli, in breve, fu tale e sì grande che fra viventi e non aveavi cui cedesse il primato, salvo l'imperatore Alessio; unico questi a lui superiore nella fortuna, nella forza della parola, nel consiglio ed in tutti i naturali doni, uomo nato per essere invittissimo se l' età sua, le sue speranze e la condizione de' tempi messo non lo avessero a contendere col mio genitore.
*) Sulla precoce preparazione scolastica di Anna Comnena è da dire che i ragazzi erano messi subito di fronte alla realtà della vita, facciamo l’esempio di Marco Polo portato in Cina dagli zii a dodici anni; mentre Anna scrive che a otto anni (come riferiamo nella cit. Scheda S. sull’Alessiade) aveva già dimestichezza con la facilità di Isocrate, l’eloquenza di Pindaro la veemenza di Polèmone, la musa di Omero e la lira di Saffo, autori (esclusi Omero e Saffo), di cui non si ha conoscenza neanche al terzo liceo classico attuale; rispetto ai giovani medievali è evidente che siamo mentalmente in ritardo di dieci e più anni.
LA BATTAGLIA
NEL MARE E NELLA PIANA
DI DURAZZO
|
C |
on il rimanente della flotta Roberto giunse a Durazzo, governata dal patrizio Giorgio Paleologo, che fu così assediata oltre che da terra anche dal mare (1081).
La flotta veneziana si dispose a mezzaluna; i normanni non erano più quelli che avevano solcato gli oceani giungendo in Groenlandia o affrontando i pericoli del Mediterraneo; la loro flotta era sotto il comando di Boemondo ma ben poco potette fare contro le navi dei veneziani che con l’abilità delle loro evoluzioni, la maniera in cui erano disposti con gli arcieri saliti sui pennoni, il fuoco greco dato in prestito dall’imperatore, decretarono la vittoria dei greci; alcuni vascelli furono presi, altri si rifugiarono sulla costa, il mare e le rive furono coperte di rottami di vascelli, di armi e di cadaveri; quasi tutte le munizioni furono inghiottite dal mare.
La notizia fu immediatamente portata alla tenda di Roberto; sfortuna volle che nel campo dei normanni si diffuse una malattia pestilenziale che decimò cinquecento cavalieri; Roberto subì una perdita di diecimila soldati per cui si vide costretto a farsi mandare aiuti dalla Puglia e dalla Sicilia e diede quindi inizio all’assedio, predisponendo le sue macchine per la scalata delle mura della città.
Era stata portata una torre mobile con in cima una enorme petriera da cui lanciare sassi, con una grossa porta che doveva fungere da ponte per l’accesso alle mura e all’interno cinquecento soldati; ma i normanni non conoscevano la forza del fuoco greco e non avevano ricoperto la torre con il cuoio, per cui fu presto incendiata e i soldati che vi si trovavano all’interno arsero vivi; fu quindi allestita una scala fatta di corde, ma essa cedette sotto il peso dei soldati che precipitarono schiantandosi al suolo.
* * *
|
A |
lessio da poco eletto imperatore si trovava a Costantinopoli e i veneziani gli portarono la notizia dell’arrivo dei normanni a Durazzo, ma era privo di soldati e di oro e argento, ma ricorrendo agli oggetti preziosi delle chiese, in poco tempo riuscì a mettere insieme un’armata di settantamila (?) mercenari di tutte le razze, di religioni e di lingue, russi, franchi, tedeschi, bulgari, alani, inglesi, macedoni, tessali, turchi, armeni, varanghi e tanti altri con la sua guardia del corpo, composta di cavalieri riccamente equipaggiati e coperti di armi d’argento.
Il falso Michele si presenta a Durazzo arringando gli abitanti ma fu ricoperto di ingiurie; Guiscardo furioso si avventa contro i nemici, dopo aver incitato i suoi soldati: “Distruggiamo questi eretici, Dio marcia alla vostra testa” e lanciandosi sugli avversari li sorprende e li disperde, massacra i turchi ausiliari e mette in rotta il resto dell’armata e dopo questa furiosa battaglia in cui, come vedremo, si era distinta Sichelgaita (v. sotto in Roberto secondo A. C.) che come suo marito era rivestita dall’armatura e sul casco aveva la corona e maneggiava la spada con fierezza e sebbene ferita al braccio, continuava a combattere!
Giunto l’imperatore, fu convinto dai più giovani ufficiali ad attaccare; Guiscardo che alle spalle si trovava chiuso dal mare, arringò i suoi: “l’imperatore è abituato alle guerre e ai trionfi; non possiamo salvarci se non con l’obbedienza e l’unione e sono pronto a cedere il comando a un generale più abile”, l’acclamazione ricevuta lo rassicurò della loro stima e della loro fiducia ... anche Sichelgaita a cavallo incoraggiò i soldati; intanto Roberto per evitare la fuga dei suoi aveva fatto bruciare le sue navi e i bagagli “combattiamo, disse, come se questo luogo sia quello della nostra nascita e della nostra sepoltura”.
Al primo scontro nonostante il tradimento del re di Serbia, Pietro III Bodin (1072-1106) alleato di Alessio che si sottrasse alla battaglia, gli arcieri greci dettero un terribile colpo mortale all’armata normanna ridotta a quindicimila uomini; longobardi e calabresi si diedero alla fuga verso il mare dove però trovarono le navi veneziane che rivolsero le macchine contro di loro; Sichelgaita pur ferita rimase sul campo di battaglia riunendo le truppe disperse e esortandole con il suo esempio, con Guiscardo che urlava “dove fuggite, il nemico è implacabile e la morte è meno spiacevole della schiavitù” e così i normanni ne uscirono vittoriosi sconfiggendo l’armata imperiale; Anna Comnena, pur raccontando le prodezze del padre (che si era dato alla fuga), scrive che egli a stento riuscì a salvarsi; l’impostore Michele combattendo, trovò una morte onorevole.
Poiché era sopraggiunto l’inverno i normanni, accampati nelle tende, per ripararsi dal freddo, costruirono delle baracche di legno; Alessio aveva fatto l’errore di richiamare Giorgio Paleologo, affidando la città a un veneziano (Malaterra ci dice che si chiamava Domenico al quale sarebbe stato affidato il compito di difendere la torre maggiore dell’isola), al quale Guiscardo promise un ricco matrimonio con la nipote, figlia del fratello Guglielmo, di particolare bellezza, assieme a ricche rendite; Domenico accettò e dall’alto delle mura lanciò delle corde e gli isolani all’improvviso si trovarono per le strade, di fronte, i normanni e reagirono, ma dopo tre giorni di combattimenti per non vedersi la città distrutta, si arresero.
Il Guiscardo dopo essersi impadronito della città (1081) proseguiva per l’Epiro, la Macedonia e la Tessaglia senza incontrare ostacoli in quanto le varie città seguendo l’esempio di Durazzo gli aprivano le porte; giunto a Larissa capitale della Tessaglia, dovette sospendere l’occupazione in quanto gli era giunta notizia che in Italia era scoppiata una rivolta dei baroni e dalla Germania stava arrivando il re Enrico (*); per cui, dopo aver affidato l’esercito al figlio, parte per la Puglia.
Boemondo mette sotto assedio Larissa che conteneva tesori e magazzini dell’armata greca, ma nel frattempo sopraggiunse Alessio con il quale vi furono degli scontri.
I successi delle due armate erano stati alterni; Boemondo mostrò tutto il suo coraggio; ma la città era imprendibile, e molti cavalieri di Boemondo o perché scontenti o probabilmente corrotti, lasciarono i propri vessilli e passarono al servizio dell’imperatore; Boemondo non potendo fare altro, abbandonando le conquiste che non poteva difendere, se ne tornò in Italia ben accolto dal padre che si era reso conto che il figlio non avrebbe potuto fare diversamente, mentre l’imperatore se ne tornò a Costantinopoli.
Roberto, dopo aver liberato Roma da Enrico IV, si preparò a tornare in Oriente (Ottobre 1084) dove aveva riportato una strepitosa vittoria nei confronti di Alessio il quale, nel frattempo, ritenendo che prima o poi Roberto sarebbe ritornato, si era organizzato con l’esercito, chiedendo ancora aiuto ai veneziani.
Al sopraggiungere dell’inverno Roberto sospende le operazioni e al ritorno della primavera, mentre sogna la conquista di Costantinopoli, cade vittima di una epidemia e muore nella sua tenda (1085) nell’isola di Cefalonia (**), all’età di settant’anni: Alessio non potette che gioire della scomparsa di questo terribile nemico che gli aveva fatto temere la perdita dell’impero; Anna Comnena gli rende omaggio (v. nota sopra) considerandolo “eccellentissimo capitano, urbano e piacevole nei suoi discorsi, pronto di mente, di maestoso aspetto, volto e persona, di affabile disponibilità; all’eroica sua taglia corrispondeva una lunga chioma cui bellamente univasi folta e lunga barba; bramoso del proprio onore non meno dell’altrui, largheggiava in generosità”... ma la principessa che aveva scritto il libro nella esaltazione della figura paterna, coglie l’occasione per esprimere il suo rammarico per la perdita da parte del padre, della battaglia di Durazzo!
Roberto lasciava come eredità al figlio Boemondo solo la spada (la sua linea di Puglia si estinguerà), e con quella spada Boemondo (in occasione della prima crociata), si impadronirà di Antiochia e costituirà un principato (***), instaurando, attraverso il nipote Tancredi, una propria dinastia.
*) Alessio per liberarsi del Guiscardo aveva inviato ambascerie presso Enrico IV invitandolo a scendere in Italia dove i vassalli, e per di più anche due dei nipoti di Roberto (Ermanno e Abelardo figli di Umfredo), erano in rivolta e gli inviava ricchi doni (centoquarantaquattromila pezzi d’oro e cento pezze di seta) e promessi altri (duecentosedici pezzi d’oro e il ricavato di venti imposte della corte) oltre agli “usuali” doni portati dagli ambasciatori: una croce pastorale incrostata di pietre preziose, un calice di sardonica, una coppa di cristallo e una corona d’oro e del balsamo.
Enrico quindi era sceso in Italia mettendo sotto assedio Roma e Roberto, chiamato dal papa (dal quale sperava di ottenere la sovranità di Roma o la corona imperiale), liberò la città dall’assedio.
**) Anna Comnena precisa che Roberto si trovava sul promontorio di Cefalonia quando fu colto dalla febbre e chiese dell’acqua; uno di quegli abitanti riferì che nelle vicinanze vi era l’isola di Itaca dove si trovava una città abbandonata, nominata Gerosolima, con una fonte di acqua limpida e potabile; a Roberto era stato vaticinato che sarebbe morto a Gerusalemme; a sentire quel nome Roberto capì che i suoi giorni erano contati e dopo sei giorni morì; Anna precisa di non saper dire se morì di febbre o di dolore ai fianchi ma si mostra molto scettica nei confronti degli studi di astrologia che considera “fantasticherie” e degli astrologi che “trovano sostentamento per la loro vita e fanno vaticini per guadagnarsi il favore dei grandi”!
***) Relativamente alla conquista di Antiochia è da dire che Boemondo, e gli altri crociati, avevano fatto credere ad Alessio che le conquiste nei confronti dei turchi sarebbero state fatte per suo conto (in modo da divenire suoi vassalli); Boemondo aveva anche firmato un trattato (Deabolis, 1108) il quale stabiliva, alla maniera occidentale (sconosciuta in Oriente), il giuramento feudale di fedeltà, ma egli non lo osserverà e per di più, quando alla sua morte gli succederà il nipote Tancredi, questo neanche lo riconoscerà!
LE QUESTIONI POLITICHE
SI INTRECCIANO
CON QUELLE RELIGIOSE
|
E |
’ noto che a Bisanzio l’imperatore oltre alle questioni politiche doveva occuparsi anche delle questioni religiose in quanto egli non solo era capo dell’impero ma anche della Chiesa, come sancito al Concilio di Calcedonia dove era stato detto all’imperatore Marciano (392-457) “Tu sei vincitore in guerra e dottore della fede” e la maggior parte degli imperatori (scrive Coniata), non tollera di limitarsi a regnare, indossare vesti d’oro, usare beni pubblici come fossero privati ... essi pensano di trovarsi in una situazione tremenda se non appaiono anche sapienti, divini nell’aspetto, eroi quanto a forza, colmi di divina sapienza come Salomone, dogmatisti, divinamente ispirati ... interpreti infallibili delle cose divine e umane; perciò, quando si devono infliggere pene a uomini incolti e violenti che introducono dogmi inconsueti e nuovi per la Chiesa ... non sopportando di essere secondi a nessuno, introducono, giudicano e definiscono i dogmi e spesso reprimono chi non è d’accordo.
Come altri imperatori si sentiva un gran teologo e con una legge dichiarò che l’imperatore aveva diritto di erigere in metropoli i vescovadi, di regolare secondo il proprio volere l’elezione dei prelati e di disporre della Chiesa; diede al patriarca di Costantinopoli la sopraintendenza di tutti i monasteri della sua diocesi con diritto di visita; per il clero di santa Sofia, che era il più numeroso, con un numero fisso di titolari, ma uno maggiore di sopranumerari (gli uni e gli altri erano stati assunti sulla base di false testimonianze sulla loro dottrina e sui loro buoni costumi, che aveva aperto la strada all’ignoranza e al libertinaggio) l’imperatore ordinò un nuovo esame e volle che quelli che fossero stati riconosciuti incapaci o dissoluti fossero sospesi dal patriarca dalle loro funzioni, fintanto che si fossero bene istruiti e corretti moralmente, ingiungendo al patriarca di innalzare a maggior dignità chi lo meritava facendoglieli conoscere affinché potesse onorarli del suo favore (ma era un modo astuto per dare la sua approvazione!); inoltre dispose che per coloro che non si fossero emendati, il sinodo dovesse provvedere a cancellarli dal ruolo di ecclesiastici.
Proprio durante il suo regno ebbe l’opportunità di trattare argomenti teologici in ben cinque casi di eresie, introdotte da Giovanni Italo, da Nilo e Blachernite, dai bogomili, dai pauliciani e infine dai manichei e, per di più, dalla rivolta del vescovo Leone di Calcedonia il quale, quando Alessio aveva dovuto usare le truppe contro i peceneghi (v. manichei, sotto), si era trovato senza danaro (come già si era verificato con Roberto Guiscardo) e aveva chiesto alle chiese di inviare i loro beni preziosi; il vescovo Leone di Calcedonia si oppose e Alessio non gli perdonò l’opposizione e se ne mostrò risentito; Leone rispose in termini violenti che suscitarono uno scandalo e fu deferito al Sinodo che istruì un processo, che ebbe luogo nel gran Triclinion del palazzo delle Blacherne, diretto personalmente dall’imperatore (presente non solo il clero, rappresentato da tutti i vescovi delle città greche, ma anche il senato, con tutti i grandi personaggi che lo rappresentavano e il console dei filosofi, all’epoca Teodoro di Smirne) indirizzato sul culto delle immagini, nella differenza se la venerazione dovesse essere della “dulia” (sketikos, culto reso a un santo) o della “latria” (latreutikkos, culto reso a Dio).... (siamo alle sottigliezze bizantine!): il Concilio si espresse nel senso che il culto alle immagini dovesse esser reso come “dulia” e Leone fu deposto e esiliato a Suzopoli del Ponto.
*) La questione riguardante la differenza tra iconoclasti e iconoduli, è molto complessa, le cui qualificazioni e distinzioni dottrinarie non risultano neanche uniformi (ne abbiamo parlato in capitoli precedenti), ma semplificando, i primi ritenevano che l’immagine fosse l’oggetto di venerazione e invocazione con l’onore reso direttamente al santo o alla immagine che lo rappresentava, nel secondo caso l’immagine serviva solo da mezzo di intercessione.
GIOVANNI ITALO
NILO E BLACHERNITE
PAULICIANI E BOGOMILI
I MANICHEI E LA STRAGE
DEI PECENEGHI
GIOVANNI ITALO
|
G |
iovanni Italo (anche G. Longobardo*), nato verso il 1030, proveniva dall’Italia meridionale; secondo quanto racconta di Anna Comnena da “bambolino tenerello, al di sotto dell’età voluta per intraprendere la carriera militare” il padre soldato nell’esercito bizantino, lo portava con sé per fargli apprendere l’arte militare e lo aveva portato in Sicilia durante la spedizione guidata da Giorgio Maniace (1038-40) il quale si era impadronito dell’isola; il padre poi dovette abbandonare l’isola per trasferirsi in Lombardia (*) da dove, senza che se ne conoscano i motivi, si recò a Costantinopoli, città fiorente di studi.
Durante il regno di Michele VII Ducas (1071-78) Italo “non manchevole di erudizione e di ammaestramenti di logica” godette del favore dell’imperatore e dei suoi familiari e frequentando le deputazioni scolastiche, (tra l’altro era stato allievo di Michele Psello, poi gli si rivoltò contro), divenne un “logico”, e in possesso di mente lucida trovava modo di porre (deliberatamente, “con furibondo e torvo occhio!), al suo maestro, questioni dogmatiche dalle cui “insidie Psello si divincolava coll'aquilina prontezza del suo ingegno e sorvolava le avviluppate astuzie dell'importuno sofista, facendolo entro se stesso ribollire di sdegno e digrignare, quindi contorcere e montare in aperta collera”
Subentrato al maestro nella carica di console dei filosofi, conquistò una discreta popolarità tra gli alti dignitari e i rappresentanti del clero patriarcale di S. Sofia.
Filosofo di scuola, raccoglitore di estratti, commentatore di Aristotele, Platone, Porfirio, Ammonio, Proclo e Giamblico, fu particolarmente attratto dai virtuosismi della dialettica e della logica aristotelica, ma, secondo Anna Comnena (che faceva le pulci al sapere dei personaggi colti, come le aveva fatte allo stesso Psello!) “era privo di un’adeguata conoscenza della letteratura patristica e incerto nel vocabolario teologico” (v. in Schegge, Anna Comnena e l’Alessiade).
Durante il patriarcato di Cosma (1081) fu sottoposto a un primo processo di eresia, ma solo le dottrine incriminate (riguardanti l’interpretazione, con argomenti razionali, dell’incarnazione, la superiorità delle dottrine dei filosofi antichi rispetto alle tradizioni ecclesiastiche, la ripresa delle dottrine platoniche sul mondo e sull’uomo, la negazione dei miracoli), furono esposte in forma anonima (probabilmente per l’intervento dell’imperatore) furono condannate all’anatema.
Nel 1082 si arrivò tuttavia a una condanna aperta e Italo fu costretto a ritirarsi in un monastero; tra le sue opere, oltre alle “93 Quaestiones quodlibetales” (i “quodlibet” erano argomentazioni che venivano poste per la discussione), il commento ai libri II-IV dei “Topici” aristotelici e studi sui sillogismi, l’interpretazione, la dialettica e la retorica.
*) La Puglia per i bizantini costituiva il “thema” di Lombardia e si considerava Lombardia anche il principato longobardo di Benevento, conquistati da Roberto.
NILO E BLACHERNITE
|
P |
oco dopo Italo (“successore della costui demenza” A. C.) apparve in Costantinopoli un eremita di nome Nilo, meno turbolento di Italo e con l’apparenza di una semplice e moderata virtù, “per poco non fece correre alle anime pericolo di naufragio intorno alla fede” (A. C.).
Costui ritenuto “privo di studi”, durante la solitudine del suo romitaggio (non se ne conosceva la provenienza), si era dedicato al solo studio delle Sacre Scritture (“senza avere chi gli appianasse la via per penetrare i reconditi concetti e senza spendere tempo nello studio dei Santi Padri” A. C.) e si era formato una dottrina che non corrispondeva a quella della Chiesa e quando ritenne di aver acquisito nozioni sufficienti per divulgarla, abbandonò il suo ritiro si recò a Costantinopoli dove, con la sua aria dura e selvaggia, “con la rigidezza del viver suo manifestantesi dallo squallore del volto e delle vestimenta” (A. C.) riuscì ad avere un seguito di ammiratori, in particolare gli armeni sempre pronti a contestare gli “ammaestramenti ortodossi”; le donne in particolare lo ospitavano per ascoltarlo, suscitando entusiasmo; egli divulgava le sue idee teologiche e riteneva di svelare il segreto dei misteri e la rozzezza del suo linguaggio era considerata come semplicità evangelica e lo facevano apparire dotto e ciò che diceva, faceva ritenere di avere conoscenze occulte ancora più profonde; ma non erano convincenti le sue spiegazioni (a dire anche di A. C.), sulla unione ipostatica delle due nature di Gesù (vale a dire quella umana e quella divina, (si rifaceva evidentemente alla eresia di Eutiche che le negava riconoscendo solo la prima, quella umana!) e difatti A. C. ci dice che “egli sosteneva che “l’umanità di Cristo era stata di sua natura, deificata” intendendo quindi che Cristo fosse solo persona umana (come d’altronde ritengono i laici!).
L’imperatore, venutone a conoscenza avendo saputo che le sue eresie avevano credito in Costantinopoli, volle ascoltarlo e gli espresse il concetto delle due diverse figure di Gesù, ma inutilmente in quanto Nilo si disse disposto a subire la prigione o l’esilio ma non rinunciava alla sua opinione.
Gli armeni che vivevano a Costantinopoli, per la maggior parte legati alla dottrina di Eutiche (come detto), alla quale si avvicinava quella di Nilo, pur di discostarsi dalla dottrina ortodossa, erano i più zelanti dei suoi seguaci, credendo appunto nella assunta umanità della natura deificata di Cristo.
Alessio ritenendo di fermare il dilagare di questa eresia si era fatto condurre in sua presenza Nilo, ma i suoi tentativi di spiegargli la natura ipostatica di Cristo erano riusciti vani i suoi tentativi di convincerlo, neanche con le minacce di prigione, di tortura, di mutilazione e di altre pene (abbiamo visto in materia religiosa, quanta forza imprime il fanatismo!) Nilo è consegnato al vescovo che, riunito un sinodo, fu riconosciuto pertinace nei suoi errori e fu pronunciata nei suoi confronti l’anatema.
Nello stesso periodo fu condannato anche un certo Blachernite il quale sebbene sacerdote si era lasciato andare a credere empie credenze, opposte a quelle della Chiesa infettato dal morbo degli “entusiasti” (*) che aveva trovato seguito tra molte famiglie e anche questo portato alla presenza dell’imperatore non volle sentir ragione e fu consegnato al tribunale ecclesiastico, anch’egli anatemizzato.
Alessio in questi ultimi anni, aveva subito dei complotti, l’ultimo di questi che riportiamo come esempio di ciò che abbiamo detto all’inizio dell’articolo (a proposito dei falsi personaggi e impostori), questa volta si trattava di un “omiciattolo nato dalla peggior feccia di campo” (A. C.), che diceva di essere figlio primogenito dell’imperatore Romano Diogene (del quale si avevano prove che era stato ucciso presso Antiochia nella battaglia con i turchi ma raccontava di essere stato solo ferito da una freccia), il quale si rivolse ai comani chiedendo il loro aiuto per esser messo sul trono d’Oriente; la loro numerosa e irriducibile armata occupò la Tracia e la Macedonia ponendo sotto assedio Adrianopoli; l’imperatore li raggiunse con le sue truppe ma raggiunti i nemici si rese conto di non poterli affrontare perché il numero era enorme.
I due eserciti si fronteggiavano quando un guerriero comano si avvicina al campo greco e sfida il più valoroso di essi; la sua statura era gigantesca, il suo aspetto selvaggio le sue armi pesanti incutevano spavento, ma nessuno si fece avanti per affrontarlo; Alessio indignato esce dal campo lo affronta e lo trapassò con la sua spada da parte a parte; così le sue truppe incoraggiate affrontano il nemico che batte in ritirata; quanto al falso Diogene, un greco travestito si reca nel suo campo e conquistata la sua fiducia lo porta in una vicina città dove è arrestato; i comani venutine a conoscenza, si ritirano nel proprio paese.
*) Questi “entusiasti” erano detti anche adelfiani, eucheti, massiliani, psalliani e sataniani e asserivano che la Sacra Scrittura dovesse essere interpretata in conformità alla ispirazione dichiarandosi pieni di Spirito divino ed essere tutti in obbligo di pregare incessantemente, abbandonando qualsiasi altro esercizio; essi non digiunavano e rigettando i Sacramenti, attribuivano l’efficacia di rimettere i peccati, di scacciare i demoni e di vedere con gli occhi corporei l’Essenza divina; usavano improvvisamente mettersi a saltare ritenendo di calpestare a questo modo i demoni e simulando di schioccare le dita fingevano di tirare frecce contro i demoni.
I BOGOMILI
|
P |
ressappoco durante il periodo di invasione dei normanni si stava propagando una nuova setta i cui adepti avevano preso il nome di “bogomili” che si diffondeva in gran segreto (il nome derivava dal bulgaro bog e milon che equivaleva all’invocazione greca kyrie-eleison con cui si invoca la misericordia divina); il loro capo, un bulgaro di nome Basilio (secondo Zonara era molto avanti negli anni, “se è vero, che ne aveva impiegati quindici nel formare il sistema dei suoi deliri e cinquantadue nello spacciarli”; questa nuova religione si fondava su diciassette principi (*).
Secondo Basilio tutti i settari concepivano il Verbo e lo partorivano come lo aveva concepito e partorito la Vergine e l’umanità di Gesù non era che una falsa apparenza; facevano frequenti orazioni dalle quali escludevano la Trinità; si astenevano dalle carni e altri cibi.
L’eresiarca era un medico di nome Basilio che indossava un abito di monaco (ma rappresentava il Diavolo scrive Zonara) ed era seguito da dodici fanatici che egli chiamava apostoli; egli “mascherava la dissolutezza dei suoi costumi sotto le più modeste e austere apparenze” e di norma per non farsi scoprire, mascherava la sua dottrina quando si accorgeva che potesse essere scoperto; con tali precauzioni era riuscito per lungo tempo a tener segreta questa sua dottrina: “era un serpente (scrive ancora Zonara) che si muoveva nelle tenebre” e prima di essere conosciuto aveva infestato un gran numero di persone; avendo però la vanità di ammettere anche le donne tra i suoi proseliti, ben presto si manifestarono i suoi errori (aveva vomitato il veleno della sua iniquità scrive Zonara) e questa nuova teologia fece un grande strepito in Costantinopoli.
L’imperatore che si considerava un teologo volle assicurarsi personalmente di questo nuova religione e alcuni seguaci messi sotto tortura rivelarono che il loro capo era Basilio; l’imperatore (volle assistervi anche il fratello), fattosi condurre Basilio lo rassicurò che desiderava conoscere personalmente i suoi misteri (ma in una vicina sala vi era un segretario che scriveva ogni cosa).
Basilio finalmente rivelò tutti i capitoli (*) su cui si basavano i suoi principi; dopo esserne venuto a conoscenza, l’imperatore, subdolamente gli disse che riteneva che dovesse essere ascoltato dal patriarca, convocato unitamente al clero e al senato, ai quali l’imperatore fece leggere i principi enunciati e trascritti dal segretario.
Basilio colto di sorpresa cercò di giustificare i suoi dogmi dei quali era tanto convinto che li avrebbe sostenuti fino alla morte, anche la più crudele; egli peraltro era convinto che non la temeva, come non temeva i supplizi in quanto trovandosi tra le fiamme sarebbero scesi gli angeli a salvarlo.
Anche tenendolo in prigione l’imperatore non riuscì a smuoverlo dalle sue convinzioni (tra gli arrestati vi erano anche i dodici apostoli).
Alessio che amava ricorrere agli stratagemmi, fece allestire nell’ippodromo due grandi cataste di legno, una delle due aveva davanti una grande croce; vi fece portare tutti i bogomili arrestati e disse loro: “Io vi credo tutti colpevoli rei di una sì mostruosa eresia, che meritano il fuoco anche quelli che ne sono sospettati; pure ho voluto distinguere gli ostinati da coloro che sono semplicemente accusati; chi dunque non è colpevole dell’eresia e se ne pente, morirà sotto le braccia della santa croce e questo rogo lo preserverà dalle fiamme dell’inferno che egli ha meritato; i nemici della croce, invece, saranno gettati nell’altro rogo”.
I soldati incominciarono a eseguire gli ordini, il popolo mormorava per l’ingiustizia che si stava commettendo in quanto si confondeva il giusto col reo; i condannati si divisero, una parte avvicinandosi alla croce, gli altri allontanandosene, si disponevano a morire lontani dalla croce. Alessio, alzatosi dal trono ferma tutto dicendo a quelli che si erano avvicinati alla croce che li perdonava rimettendoli in libertà, mentre gli altri li faceva riportare nelle carceri, consegnando Basilio al patriarca Niccolò il quale con tutto il clero lo processò emettendo sentenza di condanna.
L’imperatore dopo averlo insistentemente pregato di redimersi, lasciò che la sentenza fosse eseguita: anche questa volta furono allestite altre due cataste, una con la croce; vi era una gran moltitudine di popolo e fu data a Basilio la scelta di rinunziare al suo errore prestando omaggio alla croce o di perire tra le fiamme.
Basilio vedendo tra il popolo molti dei suoi seguaci, “con aria intrepida” li invitava ad assistere all’arrivo degli angeli, ma quando fu acceso il fuoco e le fiamme giungevano all’altezza dell’obelisco incominciò a tremare, a piegarsi, a battere le mani, a percuotersi, a battersi la coscia, a volgere gli occhi all’indietro, ma vedendo la croce si rivolse verso il rogo; l’imperatore gli fece di nuovo promettere la grazia qualora avesse rinunziato ai suoi errori; Basilio, come fosse fuori di sé non ascoltava queste richieste e alzava il volto al cielo, come se aspettasse gli angeli che lo avrebbero soccorso; gli fu tolto il mantello e gettato nelle fiamme e questo bruciò immediatamente e nella sua illusione esclamò:- “Popolo vedete che se ne vola in cielo senza essere stato toccato”; l’imperatore, di fronte a un tal delirio lo fece buttare tra le fiamme; poiché erano stati tratti di prigione gli altri seguaci il popolo gridò di trattarli come il loro maestro e alcuni di loro erano stati presi per essere buttati tra le fiamme, ma l’imperatore si oppose e li fece ricondurre nelle prigioni.
Anna Comnena aveva osservato che l’eresia si era divulgata in tutta la Grecia e l’avevano adottata le migliori famiglie di Costantinopoli; sebbene Alessio avesse usato ogni mezzo per estirparla, essa si propagò durante il regno dell’imperatore Giovanni II e anche dopo, trovandosene tracce anche nel XIIImo sec. .
L’imperatore fece comporre un’opera dal patriarca Eutimio Zigabene in cui erano confutate tutte le eresie (bogomili compresi), emerse nella Chiesa dal suo sorgere, al quale fu dato il titolo di Panoplia Dommatica.
*) 1) Approvavano solo sette dei libri della Sacra Scrittura; 2) Nell’escludere principalmente la Genesi si rifacevano al sistema dei manichei ammettendo due principi (il Bene e il Male); 3 Molte parti (non storiche?) della Sacra Scrittura erano prese come allegorie; 4 Ammettevano in Dio un corpo, non materiale ma formato di una materia più sottile e eterea, come gli antropomorfiti; 5) Non consideravano nella Trinità l’essenza divina se non nel Padre e le altre due persone erano considerate come semplici attributi; 6) Ritenevano Gesù Cristo lo stesso Arcangelo Michele, creato da Dio perché si opponesse al principio del malvagio; 7) Asserivano che un certo Satanele lanciato sul Caos che allora era invisibile e informe, al fine di gareggiare con l’eterno Padre, avendo tenuto consiglio con gli Angeli suoi seguaci, aveva creato la Terra (la descrizione del sistema bogomiliano era stata imitata da Milton nel II Canto di “Paradiso Perduto”); 8) Sulla creazione dell’uomo narravano che Satanello , avendo impastato della terra con l’acqua, aveva creato un corpo da cui, scorrendo l’acqua in giù, si era formato un serpente che non sapendo come animarlo, aveva chiesto aiuto al Dio Padre, con la condizione – che aveva ottenuto - che una tal creatura sarebbe divenuta comune ad entrambi e avrebbe potuto occupare le vuote sedi del Cielo; 9) Questo Satanello , cambiatosi in serpente, si era accoppiato con Eva e aveva generato Caino, per la qual colpa il Dio Padre lo aveva privato del divino aspetto e della facoltà di creare; 10) Che i Demoni avevano tanta possanza che ad essi Gesù Cristo e lo Spirito Santo non potevano resistere, ma solo il Padre Eterno; 11) Che questi Demoni avevano ciascuno la propria abitazione in un corpo degli uomini e li costringevano a tutte le iniquità; 12) Che per recuperare le celesti fedi, avevano procurato di ottenere figliuolo da rapporti con le femmine, dal quale erano nati i Giganti i quali unitisi con gli uomini per combattere Satanello, da questo erano stati annegati col Diluvio; 13) Che essi nell’insegnare la loro dottrina avevano lo stesso merito che aveva avuto Maria Vergine nel dare al mondo il Verbo Incarnato; 14) Che bastava il Battesimo interno senza necessità di prendere l’esterno con l’acqua lustrale, per cui se qualcuno abbracciava la loro setta tornavano a ribattezzarlo alla loro maniera imponendogli sul capo il Vangelo di san Giovanni e invocando lo Spirito Santo; 15) Rigettavano parimenti l’Eucaristia dicendo che dovevano farlo non con la bocca corporea ma con l’anima, recitando l’orazione domenicale; 16 Giudicavano il matrimonio erre impurità e opera dei demoni; 17) Disprezzavano i vescovi e tutti gli altri ministeri ecclesiastici.
I PAULICIANI
CASTIGATI
DA ALESSIO
I pauliciani (A.C. chiama spesso i pauliciani, manichei): era una setta scaturita da quella manichea (v. sotto), discepoli di un armeno di nome Costanzo che faceva parte di quella setta, il quale per evitare l'odio verso costoro (verso l' anno 788), nominò i suoi segnaci pauliciani, facendo intendere che professavano le dottrine di S. Paolo.
Sotto la protezione dell' imperatore Niceforo crebbero molto in numero; divenuti loro capi altri due armeni, Paolo e Giovanni presero la denominazione di paolo-giovanniti.
Essi riconoscevano la validità del battesimo pronunziando le parole: “Ego sum aqua viva” e per la consacrazione proffererendo: “Accipíte, manducate et bibite” (prendete, mangiate e bevete); proibivano di fare l’elemosina per non fornir cibo” a creature derivanti dal principio malefico”.
Un loro corpo faceva parte, come altri, dell’esercito di Alessio, ma non volendo combattere, si erano tirati fuori; Alessio pensò a una punizione e non volendo ricorrere a una aperta guerra, scrisse loro invitandoli con belle promesse a un incontro al quale i pauliciani aderirono.
Quando giunsero, Alessio espresse il desiderio di volerli conoscere tutti singolarmente, a ciascuno chiedeva il nome, facendolo scrivere, dopodiché chiese che si presentassero dieci per volta per agevolare il colloquio e furono introdotti secondo l’elenco che era stato formato con l’indicazione dei nomi; man mano che questi arrivavano, le guardie, presi i loro cavalli e le armi, li conducevano nelle prigioni assegnate ad ognuno di essi; nessuno di quelli che seguivano sapeva della sorte di coloro che li avevano preceduti e così a questo modo l’imperatore ebbe nelle sue mani i capi della ribellione ai quali confiscò i beni donandoli ai soldati “che pieni di costanza e valore prestato, avevano affrontato i pericoli delle battaglie”; ma a seguendo la sua indulgente natura, scrive lo storico, a poco a poco ne mitigò di molto la pena, facendo battezzare e rientrare nell’ortodossia chi lo avesse accettato; i capi ispiratori della rivolta furono banditi e confinati nelle isole, mentre agli altri consentì di stabilire la propria dimora dove preferivano, ed ciascuno di essi se ne tornò nel proprio paese.
I MANICHEI
E LA STRAGE
DEI PECENEGHI
Dopo il Xmo sec. la religione dei manichei (*) era diffusa in Asia ed Europa; l’imperatore Giovanni Zimisce (969-976) aveva fatto dei prigionieri nelle province del nord dell’impero e questi prigionieri li aveva fatti stabilire a Filippopoli, proponendosi di farne una colonia che sarebbe servita come barriera contro eventuali invasori, che nella specie erano i peceneghi (da ricordare che la politica bizantina sostanziale, seguita da tutti gli imperatori per poter dominare le popolazioni barbariche, era quella di metterle le une contro le altre).
Purtroppo il programma di Zimisce era andato in fumo in quanto il gruppo di prigionieri non solo si era espanso in tutta la regione ma aveva formato con i manichei (una delle ipotesi era quella che si fossero convertiti al manicheismo), un fronte di opposizione che si ingrossava con l’arrivo di altri correligionari provenienti dall’Asia, costituendo una forza che opponeva ai greci la propria politica e la propria religione.
I manichei (con gli armeni, che furono i primi propagatori della religione), avevano trovato un ambiente favorevole alla sua diffusione; alla fine i peceneghi riuscirono ad affrancarsi dalla autorità dell’imperatore che ottenne il risultato contrario a quello desiderato, essendosi, peceneghi e manichei alleati negli attacchi contro l’impero o con le defezioni dall’esercito in cui servivano come forze ausiliarie.
Infatti, quando Alessio era tornato a Costantinopoli dopo la sconfitta di Durazzo, e si stava preparando a ricomporre l’esercito, il corpo dei manichei si era rifiutato di rientrare nell’esercito; egli volle quindi dar loro una lezione che servisse come esempio per gli altri corpi ausiliari e non sentendosi con forze sufficienti per andare a infliggere la punizione, invitò i capi a Costantinopoli, dove si recarono (tra la fine del 1083 e inizi del 1084) con i personaggi più importanti; ebbero però la sorpresa di essere disarmati e sentirsi privati di tutti i loro beni che sarebbero stati distribuiti tra i soldati; inoltre furono invitati a convertirsi: quelli che consentirono a ricevere il battesimo furono lasciati liberi, gli altri furono mandati nelle varie isole greche.
Questi avvenimenti però non finirono a questo punto, in quanto tra i manichei spogliati dei loro beni, vi erano due sorelle di un certo Traulos il quale era al servizio di Alessio il quale, venuto a conoscenza dei provvedimenti presi da Alessio si ribellò e andato a stabilirsi a Beliatoba (probabilmente una fortezza tra le montagne a nord di Filippopoli per poter essere vicino ai peceneghi), si mette a capo dei malcontenti e dà inizio a negoziati con i peceneghi; l’imperatore venutone a conoscenza gli manda degli ambasciatori per farsi perdonare, ma Traulos non accetta e prosegue nelle devastazioni; il pericolo per Alessio era grande in quanto i peceneghi occupavano la riva destra del Danubio e alle loro bande si univano gli ungheresi che riuscivano facilmente ad attraversare il fiume e queste bande che erano migliaia, se non decine di migliaia, escludendo i loro villaggi, devastavano il territorio dell’impero.
Alessio Iniziò una campagna di guerra con i peceneghi estenuante e di lunga durata (1088-1091) che ebbe fine con la battaglia di Leburnio (29.IV.1091) in cui gli avversari erano di una tal moltitudine, “circondati e protetti dai carri da essere insuperabile come un muro”, che i greci, spaventati, passarono la sera precedente, alla luce delle torce e candele fissate in cima alle lance, fino a mezzanotte, a chiedere l’aiuto di Dio con canti e inni sacri.
I greci, comandati dallo stesso imperatore e dai generali Giorgio Paleologo, Giorgio e Costantino Dalasseno, Monastras e Umbertopulos e Uza, e gli alleati polovizi, (comandati da Togortak e Maniak) accerchiando gli avversari a mezzaluna li attaccarono e vi fu un generale sterminio “senza riportarvi tampoco un avanzo, fatto di tutti macello” (A. C.); fu fatta una massa enorme di prigionieri tale che ogni milite greco ne aveva più di trenta da sorvegliare, come aveva suggerito Sinesio (che era stato ambasciatore presso i peceneghi), all’imperatore, al quale gli aveva consigliato di eliminarli tutti perché se si fossero liberati sarebbero stati loro a uccidere i propri guardiani; ma l’imperatore (nel racconto di Anna), si era energicamente opposto rispondendogli tra l’altro che il suo suggerimento era un delirio.
Il mattino seguente nell’accampamento si vide uno spettacolo raccapricciante, durante la notte era stata compiuta una strage di inaudita crudeltà in quanto i prigionieri erano stati trovati tutti sgozzati, comprese le donne e i bambini; l’imperatore, fatto chiamare Sinesio che riteneva essere stato l’istigatore lo fece legare, in attesa della punizione, ma un gruppo di polovizi lo fece fuggire portandolo verso il Danubio.
Di questa strage rimase un tal ricordo che a Bisanzio si diceva che “Per un sol giorno gli sciti (così A. chiama i peceneghi) non videro maggio”; in poche ore, scrive A. C. , “era stato sterminato un popolo fiero, misleale, terribile per immenso numero di gioventù bellicosa e sempre molesto”; da quel giorno però i peceneghi furono messi nella condizione di non nuocere in quanto non potettero più contare sull’aiuto di altre popolazioni spaventate dalla strage; gli stessi alleati polovizi temendo un analogo destino, fuggirono senza reclamare il bottino che Alessio glie fece recapitare.
*) Il manicheismo, (il termine manicheo è usato in riferimento a posizioni rigorose o dogmatiche) come tante altre religioni, era sorto nell’area mesopotamica e del medio oriente, dove era viva la creatività speculativa che aveva dato origine a diverse religioni quali lo zoroastrismo, il giudaismo, il cristianesimo, l’islamismo. Mani o Manes, il fondatore, nato in Babilonia (216-277 d.C.), era stato educato da una setta battista, di ispirazione cristiana ma considerata eretica; a seguito dei suoi viaggi fatti in India il manicheismo aveva subito influenze buddiste, oltre a quelle zoroastriane, platoniche, cristiane e gnostiche, e aveva avuto una vasta diffusione non solo nell’area mesopotamica, nel medio oriente, in Egitto, in nord Africa, ma anche in oriente, cioè India, Mongolia e Cina.
Esso fondava la sua credenza in Ahura Mashdah, il Dio supremo, primo e unico creatore, la cui caratteristica era quella che egli creava con il pensiero, e, con la forza della sua mente aveva creato la verità, e, la dottrina (ristretta in poche parole) si basava su un principio dualistico del bene e del male, della luce e delle tenebre, dello spirito e della materia, in lotta tra loro, con la vittoria della luce sulle tenebre, seguita dal trionfo della Chiesa manichea, con un Giudizio finale nel quale le anime compaiono davanti al Bema, Tribunale di Cristo, con la separazione dei buoni dai cattivi.
Molti cristiani aderirono alla dottrina manichea, tanto che gli ortodossi, visto il pericolo di fughe dei propri appartenenti, l’avevano dichiarata eretica.
PARTONO LE BANDE
DI PELLEGRINI
AVANGUARDIA DELLA
PRIMA CROCIATA
|
D |
ella prima crociata ne abbiamo già limitatamente parlato (in Art. (Art. La Ia e IVa Crociata: un business per i veneziani), in questa sede intendiamo limitarci alla partenza dei primi crociati (*) e ai rapporti che si instaurarono con l’imperatore Alessio e le loro azioni in territorio bizantino; poiché si parla genericamente di prima crociata, in cui si accomunano i primi gruppi formatisi spontaneamente al seguito di predicatori, che consideriamo pellegrini-crociati, e riteniamo tenerli distinti dai cavalieri-crociati che li seguirono successivamente.
Tra i primi troviamo quelli al seguito di Pietro l’Eremita al quale si aggiunse Gauthier Sans Avoires o Sans-Argent (Senza averi o Senza denaro); altri due gruppi partirono per proprio conto, una al seguito di Gotshalk (Godescalco), un predicatore del Palatinato che aveva predicato anch’egli la crociata (questi predicatori erano considerati uomini mandati da Dio e riuscivano, con la facondia delle loro parole, ad attrarre le moltitudini, come d’altronde si verificherà con Hitler a distanza di circa otto secoli!); l’altra si formò non molto tempo dopo, raccolta sulle sponde del Reno e della Mosella, ancora più fanatica, indisciplinata e sediziosa delle altre, senza un capo, ma tra di essi vi erano alcuni nobili come Thomas de Feii, Clairembault de Vandeuil, Guillome Charpentier, il conte Hermann e qualche altro; un sacerdote di nome Volkmar e un conte Emicone “che credevano di espiare gli stravizi di gioventù” ottennero la fiducia di costoro, convincendoli che non serviva andare a liberare il santo sepolcro quando vi erano quelli che avevano condannato Gesù Cristo alla croce, “facendo apparire miracolose visioni”, gli ebrei che esercitando il commercio avevano nelle mani la maggior parte dell’oro che circolava in Europa.
Questa crociata, scrive l’abate Fleury, “determinata dall’odio dei cristiani nei confronti dei musulmani, dall’ignoranza dei laici, dall’autorità degli ecclesiastici, dall’avidità dei monaci, da una sfrenata passione per le armi e soprattutto una diversione che sospendeva le guerre intestine che duravano da molto tempo; i laici carichi di crimini, credevano di lavarli bagnandosi nel sangue degli infedeli [....]; la crociata era servita di pretesto alle persone che non potevano pagare i propri debiti, ai malfattori per evitare la punizione dei loro crimini, agli ecclesiastici indisciplinati per affrancarsi dal giogo del loro stato, ai monaci indocili per lasciare i conventi, alle donne perdute per continuare più liberamente la loro vita corrotta”.
GUALTIERO SENZA AVERI
Da Pietro l’Eremita che prima della partenza si trovava a Colonia, si era presentato un ignoto cavaliere di nome Gauthier (sopranominato, come abbiamo detto, Sens-avoir-Gualtiero Senza Averi), provvisto del solo cavallo e della spada e per questo sopranominato, fattosi suo luogotenente ottenne da Pietro un folto gruppo dei suoi seguaci con i quali partì in anticipo per aprirgli la strada.
Gualtiero attraversata la Germania e quindi l’Ungheria dove il re Calomanno (Kalman) gli permise di acquistare viveri; proseguì per la Bulgaria dove a Belgrado, non avendo ottenuto dal governatore il permesso di acquistare viveri, si diede a rapire gli armenti per le campagne; ma sopraggiunse subito l’esercito bulgaro che ne bruciò sessanta rifugiati in una cappella, mentre degli altri alcuni furono massacrati, altri riuscirono a disperdersi nei boschi col loro capitano; questi ultimi giunsero, dopo otto giorni, a Nissa dove era governatore Niceta, col quale Gualtiero si lamentò per quanto gli era accaduto e Niceta dopo avergli promesso che gli avrebbe fatto giustizia, gli assegnò delle guide che lo scortarono fino a Costantinopoli (20.VII.1096); qui l’imperatore gli concesse di accamparsi alle porte della città.
PIETRO L’ERAMITA
Pietro che da soldato era divenuto monaco-eremita, dopo la partenza di Gualtiero, marcia alla testa di una moltitudine di ottantamila tra fanatici religiosi e briganti scappati dalle prigioni, avventurieri avidi di bottino, monaci debosciati e prostitute, ecclesiastici, vecchi e ragazzi senza famiglia, di diverse nazionalità; egli, attraversata la Lorena, Franconia, Baviera e l’Austria, giunse ai confini dell’Ungheria dove il re Calomanno gli accordò il passaggio a condizione che fossero pagati i viveri senza fare alcun torto agli abitanti.
Giunto al fiume Sava dove erano stati uccisi i soldati di Gualtiero, i cui corpi erano ancora appesi alle mura della città (chiamata dai crociati Maleville), i pellegrini presi da furore, eccitati dal francese Burel d’Estempes, saccheggiarono la cittadina uccidendo quattromila ungheresi e dopo aver fatto dei prigionieri, proseguirono nel viaggio; ma sopraggiunsero i soldati ungheresi che attaccarono e massacrarono la retroguardia; Pietro, avvertito, ritenne inutile tornare indietro e proseguì nella sua marcia; anche in Bulgaria l’esercito bulgaro massacrò facilmente quella massa indisciplinata, mentre donne e bambini furono presi prigionieri: Pietro con cinquecento uomini si dette alla fuga ma dovette riconoscere di aver perduto diecimila uomini.
Pietro, con quello che rimaneva del suo seguito giunse a Nissa dove, dopo negoziati con i messi dell’imperatore, furono riforniti di viveri; quindi si prepararono a partire diretti a Sofia, ma partendo, gli ultimi del seguito, incendiarono dei mulini e delle case poste alla periferia della città, il governatore Niceta, li fece subito inseguire e fatti prigionieri.
Pietro che li precedeva tornò indietro per parlamentare, ma la discussione finì per trascendere e si ingaggiò una battaglia in cui i suoi seguaci furono sconfitti; si giunse alla fine a un accordo e Pietro, con il consenso dell’imperatore, potette proseguire verso Sofia con l’ordine di Alessio, che mostratosi tollerante, li perdonava per il male che avevano fatto a Niceta e consentiva loro di potersi fermare tre giorni per rifornirsi di viveri; dopodiché proseguirono per Filippopoli e Adrianopoli (due bellissime città che davano una idea di quello che poteva essere la capitale), giungendo a Bisanzio dieci giorni dopo Gualtiero (30.VII.1096) col quale si congiungeva, e il numero dei seguaci si era ridotto a ventimila!
Pietro fu subito condotto dall’imperatore: con i sandali e cinto da una corda, l’aspetto emaciato e la barba incolta, la sua bassa statura, l’abito sudicio sorpresero i cortigiani suscitando la loro repulsione, ma quando incominciò a parlare, il fuoco del suo sguardo, il calore del suo zelo, la veemenza del suo discorso suscitarono una viva impressione e il disprezzo suscitato si mutò in rispetto; egli annunciò all’imperatore che un gran numero di vescovi, principi, duchi, conti e guerrieri dell’Occidente marciavano sui suoi passi per liberare il Santo Sepolcro dagli infedeli, ma questo annuncio suscitò nell’imperatore più preoccupazione che speranze!
Alessio commise l‘errore di suggerire a costoro di attendere l’arrivo degli altri crociati, ma presto si accorse del pericolo che rappresentava quell’orda di pellegrini briganti che distruggevano le campagne e bruciavano le case, spogliavano le chiese e devastavano i dintorni della capitale e se ne liberò facendoli trasportare dall’altra parte del Bosforo in territorio confinante con quello dei selgiuchidi, raccomandando di non provocare in nessun modo i turchi.
Essi si accamparono presso una cittadina (indicata da A. C.), Elenopoli, o, secondo altre fonti in Civitot, dove, accampati e rifocillati, rimasero per due mesi senza creare problemi, con i mercanti che vi si recavano a vendere le loro merci, ma nell’assenza di Pietro che si era recato a Costantinopoli, settemila francesi e trecento cavalleggeri andarono a compiere saccheggi, spingendosi fino ai dintorni di Nicea, compiendo stragi di vecchi e adulti, mentre, per soddisfare la fame, fecero a pezzi i fanciulli poppanti e infilzati negli spiedi, li arrostivano sulla brace.
Sul loro esempio tremila alemanni e duecento cavalleggeri sotto il comando di un capitano di nome Rinaldo, andarono ad assaltare un castello (Xerigordon) appartenente a Solimano, a quattro miglia di distanza da Nicea, dove sgozzarono tutti i musulmani, lasciando vivi solo i greci; Solimano che seguiva tutti i movimenti, unite le sue forze, alla testa di quindicimila soldati si recò al castello e li passò tutti a fil di spada; Rinaldo per salvare la sua vita si fece musulmano.
I francesi, impazienti volevano attaccare Solimano, Gualtiero riuscì a trattenerli, ma dopo otto giorni uscirono dal campo in venticinquemila e cinquecento cavalleggeri, andando incontro a Solimano e dopo un combattimento, Solimano riuscì a circondarli, massacrandoli tutti; non solo, ma recatosi nel campo di Civitot massacrò ammalati, monaci, ecclesiastici, donne e bambini prendendo solo (secondo la loro usanza) giovanette e ragazzi (le prime finivano nei ginecei, i secondi, come è stato detto in precedenti capitoli, dopo essere stati convertiti, diventavano giannizzeri); della moltitudine rimasero solo tremila francesi che mandarono a chiedere aiuto ad Alessio, il quale sebbene sentisse un intimo piacere per ciò che aveva dovuto subire e sopportare, mandò le sue navi con truppe per liberarli; alla vista di questa flotta i turchi si ritirarono con i prigionieri e il bottino, mentre i cristiani furono portati a Costantinopoli dove ricevettero viveri e assistenza.
GOTSHALK
Gotshalk, il prete del Palatinato, era riuscito a raccogliere quindici-ventimila uomini che avevano giurato di combattere gli infedeli; costoro avevano attraversato l’Ungheria senza problemi, fino a quando i bavari del suo gruppo, dopo essersi ubriacati in una città, si davano al saccheggio e agli stupri, ma Calomanno mandò l’esercito che trovò nei primi una forte resistenza; il generale ungherese allora finse di voler trattare la pace e con altri ufficiali, accolto nel loro accampamento, convinse quella turba di teutoni a trattarsi come fratelli e non come nemici e spogliarsi delle armi; i teutoni si fidarono e deposte le armi, a un segnale del generale giunse l’esercito ungherese che diede inizio al massacro dal quale si salvarono i pochi che riuscirono a fuggire, tra quali Gotshalk che se ne tornò in Alemagna.
IL CONTE EMICONE
MASSACRATORE DI GIUDEI
Dopo breve intervallo da questo avvenimento, un’altra masnada di duecentomila tra francesi, inglesi, fiamminghi e lorenesi composta come le precedenti di avventurieri, prostitute, impostori e falsi profeti tra i quali vi erano anche i nobili Thomas de Feii, Clairambautlt de Vandeuil, Guilloaume Charpentier, e il conte Herman, ma non vi era un capo; un conte Emicone (al quale si unì un sacerdote di nome Volkmar), di un paese in prossimità del Reno, che aveva un seguito di dodicimila uomini e fanatico per l’odio che aveva contro giudei (**), appoggiato dal prete Volkmar, riuscì a convincere la moltitudine che, era inutile andare a liberare il Santo Sepolcro quando vi erano i giudei che avevano ucciso Cristo, con i quali poteva avere inizio la guerra che andavano a fare agli infedeli.
Tutti così convinti partirono iniziando i massacri nelle città di Magonza, Colonia e Nuys, nonostante l’intervento del vescovo di Magonza che li vide sgozzare anche nel suo palazzo; i giudei, disperati, pur di non essere massacrati, si pugnalavano da soli, le madri scannavano i loro figli, mentre gli altri cadevano sotto la spada di Emicone e dei suoi soldati; il carnefice, prese poi la strada per la Franconia e la Baviera giungendo ai confini dell’Ungheria dove Calomanno lo bloccò prima che giungessero alla città di Mersburgo (Leita); questi fanatici avevano preso come “mascotte” un’oca e una capra, ritenendoli guidati dallo spirito divino e li consultavano come se fossero oracoli (purtroppo lo storico che riferisce questo particolare, non aggiunge altro!).
Costoro chiesero al re il passaggio, ma Calomanno glielo negò, ne seguì un saccheggio e furono bruciati i luoghi vicini e uccisi settecento uomini che il re aveva mandato per difendere il paese; dopo aver fatto ciò, posero la città sotto assedio.
Calomanno in un momento di debolezza, meditava di andare a rifugiarsi in Russia quando gli assedianti, durante la notte, presi da terrore (era stato detto, ispirati dal cielo!), se ne fuggirono lasciando tutta la loro roba, disperdendosi dappertutto; Calomanno ripreso coraggio e riunito l’esercito li inseguì, alcuni furono massacrati altri fatti prigionieri; Emicone con i suoi, se ne tornò nel suo paese; mentre i nobili innanzi indicati (Thomas de Feii, Clairambautlt de Vandeuil, Guilloaume Charpentier, e il conte Herman) e qualche altro alla testa di quelli che si erano salvati, attraversata la Carinzia, si diressero in Italia e quindi raggiunsero la Puglia unendosi ai principi che avevano intrapreso lo stesso “pellegrinaggio” diretti a Durazzo raggiungendo così in Grecia.
Alessio che imprudentemente aveva scritto al papa chiedendo un aiuto contro i turchi che erano alle porte di Costantinopoli, vedeva ora il suo territorio invaso non tanto da fanatici religiosi (che in ogni caso erano in minoranza) ma da un’orda di briganti e vagabondi senza freni e senza pietà e i c.d. nobili cavalieri che li seguirono non furono da meno; i greci (e la stessa Anna) odiavano i latini già da prima che arrivassero (abbiamo visto come Alessio aveva dovuto combattere con il Guiscardo e Boemondo che gli volevano togliere l’impero); le cose peggiorarono con l’arrivo delle orde di Pietro, delle quali Gibbon aveva scritto “i briganti che lo seguivano erano degli animali selvaggi senza ragione e senza umanità”, e questo stesso giudizio si può dare dei crociati che seguirono, che furono “nobilitati solo da una storiografia retorica e esaltante”.
*) Le parole “crociate” della Settimana Enigmistica!
A tutti i livelli della comunicazione (TV e carta stampata) e non solo, si sente parlare di “parole crociate” e con tanti professori che abbiamo in Italia non abbiamo né visto né mai sentito o letto della correzione di questo errore madornale! Non si tratta delle parole dei nostri crociati o che hanno fatto le crociate o che contrassegnano una croce, ma di “parole incrociate” nel senso che sono intersecate, tagliate trasversalmente, attraversate perpendicolarmente, che vanno dall’alto in basso e da sinistra a destra che si incrociano, come le gambe incrociate, le bretelle incrociate, le spade incrociate e non segnano una croce ... per essere crociate!
**) L’ODIO NEI CONFRONTI DEGLI EBREI (*)
Dobbiamo rilevare che quest’odio contro gli ebrei era stato disseminato sin dal sorgere dei cristianesimo (che predicava la bontà ma praticava l’intolleranza; poi arriverà l’odio per i musulmani!), e un in certo qual modo se lo erano cercato anche loro con la leggenda biblica del “popolo eletto”, che aveva adottato la circoncisione in quanto Dio lo aveva chiesto ad Abramo in maniera perentoria (La tua discendenza sia circoncisa; il maschio non circonciso sia eliminato dal suo popolo per aver violato l’alleanza! Genesi 17:9-14). E’ per questo motivo che nei secoli a venire non si sono mai integrati con le popolazioni con cui convivevano, rimanendo a questo modo isolati e facile preda dei continui attacchi da parte della Chiesa e dei papi (che avevano istituito i ghetti in cui erano stati relegati!), che in ogni occasione si ripercuotevano sulle comunità credulone, con i monarchi che li assecondavano (ne abbiamo parlato in varie occasioni) e, seminando l’odio, gli ebrei erano divenuti il “capro espiatorio di tutti i mali del mondo”.
Alla persecuzione dei cristiani si era aggiunta quella dei protestanti di Lutero (1463-1546) che aveva scritto il libro “Sugli ebrei e le loro menzogne”, e così andando avanti nei secoli l’odio aveva raggiunto il suo apice in Hitler il più celebre dei massacratori, che, nella folle convinzione che gli ebrei non fossero esseri umani, ne aveva fatti eliminare sei milioni tra forni crematori e uccisioni a sangue freddo da parte dei suoi ufficiali (non solo SS) e soldati (chi potrà mai fare il conto degli ebrei uccisi in tanti secoli?).
Ma, questo sentimento di pietà per tutti gli ebrei massacrati e uccisi, nei campi di sterminio è dedicato “il giorno della memoria”, Yad Vashem (v. sito Internet) che ha solo carattere internazionale (27 Gennaio) e non nazionale; in proposito dobbiamo rilevare che in Israele pur essendovi musei che illustrano l’Olocausto esso non viene ricordato il 27 Gennaio che è solo giorno non lavorativo, in cui però non viene fatta la stessa campagna fatta all’estero e non vengano diffusi i documentari e films che vediamo nelle nostre TV.
per far .
Questo è da ritenere un grave errore: perché voler educare le coscienze altrui e non anche quelle del proprio paese a metabolizzare il ricordo di quelle atrocità che porterebbe a una maggiore predisposizione degli animi israeliani a una pace duratura con i palestinesi?
Senza voler disconoscere gli attentati provocatori della frangia degli estremisti palestinesi (che con una pace duratura non avrebbero più motivo di agire), è da dire che si è fatto di Israele un paese militarizzato, con muri e filo spinato proprio come si faceva nei campi nazisti, che alle nuove generazioni israeliane bisognerebbe far conoscere con documentari trasmessi in TV.
Lo stesso Netanyahu (seppur nato nel 1949), che nella sua giovinezza dovrebbe certamente aver sentito i racconti dei campi di sterminio nazisti, fa rabbrividire per le sue dichiarazioni e per i suoi comportamenti oltranzisti (si potrebbe dire di stile nazista!) nei confronti dei palestinesi; nessuno ricorda Isaac Rabin, martire della pace, ucciso nel 1995 da un estremista che doveva essere ricercato e punito mentre sia la Commissione nominata per indagare, sia il Mossad (servizi segreti che sono tra i migliori del mondo) lasciarono tutto cadesse nel silenzio; né ci si può attendere delle reazioni da parte dei c.d. moderati, che non prendono posizione, i quali, rimanendo passivi (ciò vale anche per gli islamici, v. in Schede: Palestinesi e Israeliani)) non fanno altro che il gioco degli estremisti!
Dobbiamo concludere che ciò che si vuole da parte israeliana è la scomparsa del popolo palestinese dal proprio territorio (questa idea non ricorda per caso il genocidio nazista?), territorio che è stato quasi tutto interamente e arbitrariamente occupato dagli israeliani che continuano ancora nelle occupazioni; infatti Netanyahu (dopo essersi assicurato l’appoggio del nuovo presidente USA Donald Trump, ritornato però sui propri passi, in quanto si è mostrato contrario a nuove costruzioni!), si è ugualmente precipitato ad accelerare i lavori di due nuovi quartieri uno per duemila e l’altro per tremila israeliani, non solo in territorio palestinese, ma anche su proprietà private palestinesi, dichiarando che:- Intendono (gli israeliani) riservargli (ai palestinesi) solo una piccola parte di territorio; e il Parlamento (Knesset) ha anche approvato con legge retroattiva (!) tutti gli espropri fatti da israeliani in Cisgiordania, che con la striscia di Gaza costituisce l’unico brandello di territorio rimasto ai palestinesi!
A questo punto chiediamo:- Non è un controsenso ricordare agli altri le atrocità e i campi di concentramento nazisti (ma comportandosi alla stessa maniera!) e non invece farne uguale campagna nel proprio paese per educare così le proprie generazioni alla pace e alla integrazione .... e magari anche alla pacifica convivenza? (v. in Schede: Israeliani e palestinesi)
*) V. anche nell’Art. L’Europa verso la fine del medioevo P. I. e in Schede S. Israeliani e Palestinesi.
ARRIVA LA BANDA DEI
CAVALIERI CROCIATI
|
A |
lessio pur nella sua astuzia (Michaud che non lo apprezzava molto, scrive che “governava solo con la dissimulazione, ordinaria politica dei greci e dei piccoli Stati”!), per liberarsi una buona volta dei turchi, come abbiamo visto, aveva chiesto aiuto al papa; egli pensava a un Occidente che avesse lo stesso grado di civiltà raggiunto dai bizantini, e riteneva che sarebbero arrivati nobili guerrieri civilizzati, che sotto il suo comando lo avessero aiutato a fare arretrare i turchi che avevano invaso il territorio imperiale, compresa la Palestina e Santo Sepolcro dove i cristiani, cattolici e ortodossi avevano convissuto senza problemi, con giudei e saraceni; ... ma si era sbagliato.
L’Occidente era ancora avvolto dalle tenebre della barbarie e Alessio fu preso da spavento quando vide il suo territorio invaso prima da una torma di banditi e poi di cavalieri, con migliaia di uomini che Anna Comnena aveva paragonato alle stelle del cielo; nella piana di Nicea si raccoglieranno cinquecentomila fanti e cinquantamila cavalieri, che pur vantando la nobiltà delle loro origini erano lo stesso barbari e incivili, avidi, spergiuri, brutali e arroganti, che non si distinguevano molto dai banditi che li avevano preceduti; egli quindi, comportandosi con astuzia, aveva li aveva mandati volentieri contro i turchi pur di impedire che essi occupassero il suo impero.
In proposito Voltaire, contrariamente agli storici (clericali) che avevano dipinto Alessio come traditore, a causa del trattamento riservato ai comandanti franchi, riteneva che “ogni persona obiettiva lo avrebbe considerato saggio e magnifico e se aveva mostrato fermezza nei confronti dei crociati, era stato perché non voleva divenire schiavo di una moltitudine armata”.
I crociati quando giunsero a Costantinopoli erano rimasti esterrefatti dalla bellezza della città, dalla magnificenza degli edifici, dei templi, delle opere d’arte, dei numerosi dei palazzi e dei monasteri che non avevano eguali in Occidente (dove le costruzioni di case e castelli erano ancora in legno), dell’abbondanza delle ricchezze, dell’attività del commercio e dell’immenso popolo educato e civilizzato che in mezzo al lusso coltivava le scienze e le lettere e si era formato un linguaggio raffinato e un tono convenzionale da gran mondo e di corte, ignorato in Occidente.
I greci a loro volta rimasero scioccati dai modi rozzi e selvaggi dei latini e dal loro carattere altezzoso, ma l’introduzione dei tornei (ancora primitivi che si raffineranno dopo le crociate come vedremo in Schde S. Le crociate e lo sviluppo dell’Occidente) dette loro l’occasione di provare la loro indiscussa perizia e valore nei combattimenti.
Un esempio della loro sfrontatezza lo darà Roberto, conte di Parigi, quando Alessio ricevette i nobili francesi, che gli rendevano omaggio; scioccato dal fasto della etichetta di corte, Roberto sale sul trono dov’era l’imperatore e gli si siede accanto; Baldovino lo riprende dicendogli che quando si era in un paese straniero bisognava rispettarne i costumi; “ohé, gli rispose Roberto, come posso sopportare che quel ridicolo villano stia seduto mentre tanti illustri capitani stanno in piedi?”; Alessio chiese spiegazione di ciò che aveva detto Roberto; quando i cavalieri stavano andando via, trattenne Roberto e gli chiese della sua nascita e del suo paese e Roberto rispose: “Appartengo alla nobiltà più illustre; non so che una cosa, al mio castello vi è una chiesa dove possono recarsi coloro che vogliono dimostrare il loro valore; ma sono rimasto per lungo tempo ad attendere qualcuno che volesse battersi con me senza che venisse nessuno”; l’imperatore, nascondendo la sua rabbia, sapendo cosa li aspettasse da parte dei turchi, ritenne dargli un consiglio, e gli disse: “Se aspettasti inutilmente i nemici tra poco potrai appagare la tua brama, ma guardati dal metterti davanti o in coda all’esercito, mettiti piuttosto nel centro, altrimenti cadrai sotto la scimitarra degli infedeli”.
Goffredo di Buglione, duca di Lorena, capo dei cavalieri, aveva venduto parte delle sue terre al vescovo di Verdun e aveva ipotecato un’altra parte al vescovo di Liegi (per 4500 marchi d’argento e una libbra d’oro) come avevano fatto (e faranno) altri cavalieri che si recavano a combattere in Terra Santa; con queste vendite, si diceva che, mentre i cavalieri cedendo i loro beni si erano impoveriti, i principi della Chiesa “con il fervore dei cristiani” si erano arricchiti!
Egli, con il fratello Baldovino e con diecimila cavalieri e ottantamila fanti si diressero (10.VII.1096), verso l’Austria e dopo averla superata in venti giorni, si fermarono ai confini dell’Ungheria, mandando a chiedere al re Calomanno, il permesso di attraversare il paese, che gli fu concesso.
Giunto alla frontiera della Bulgaria, Goffredo ricevé una lettera di Alessio che lo pregava di non commettere danni, assicurandogli la libertà di commercio; a Nissa (alle porte dei Balcani) l’imperatore gli fece fornire gratuitamente tutto ciò che poteva servire per il suo mantenimento, accordando alle sue truppe la libertà di commercio promessa e ciò valse per tutta la Bulgaria fino a Filippopoli dove l’armata giunse dopo otto giorni.
Qui Goffredo venne a sapere che Ugo conte di Vermandois, fratello di Filippo I Francia, il quale con le sue truppe era giunto per suo conto a Costantinopoli, era tenuto dall’imperatore come prigioniero.
Un altro gruppo si era formato con Roberto duca di Normandia (figlio di Guglielmo il Conquistatore) e Stefano conte di Bologna, altro fratello di Buglione, con il loro esercito, prendendo la strada delle Alpi e percorrendo la via francigena, si fermarono a Lucca dove ricevettero la benedizione del papa (che oltre al gonfalone aveva mandato propri legati che oltre a rappresentare il papa erano rivestiti della pienezza del potere spirituale, come suoi sostituti, con a capo Adémar de Monteil, vescovo di Puy il quale, anche se non considerato capo militare, esercitava una direzione superiore), visitarono a Roma i sepolcri degli Apostoli e giunsero in Puglia (nel mese di novembre) accampandosi a Bari con l’idea di raggiungere la Grecia in primavera.
Ugo di Vermandois faceva parte del seguito di Goffredo di Buglione, ma con il proprio gruppo dopo aver attraversato l’Italia si era accampato a Bari per poi congiungersi a Goffredo (che, come abbiamo visto, stava seguendo il percorso balcanico); in attesa dell’arrivo degli altri e stanco di aspettare, decise di recarsi in Grecia per conoscerla, accompagnato da tre cavalieri del suo seguito (ma qualche altro storico parla della partenza dell’intera flotta, naufragata per una tempesta), giungendo a Durazzo.
Qui era stato ricevuto dal governatore Giovanni Comneno con tutti gli onori e gli fu imbandito un pranzo; finito il pranzo, quando Ugo si stava accomiatando dal suo ospite, con somma sorpresa si sentiva dire dal governatore che non poteva farlo partire senza il permesso dell’imperatore e che un corriere era già stato mandato a Costantinopoli.
Al ritorno il corriere era accompagnato da un messo dell’imperatore, Butumite, il quale aveva ricevuto l’ordine di portarli con sé a Costantinopoli dove furono portati e trattenuti, più come ospiti forzati che come prigionieri in quanto Alessio aveva dato a Ugo una somma considerevole in argento e questo aveva prestato giuramento di fedeltà.
L’intento di Alessio era quello di tenerli presso di sé, per garantirsi che i crociati in arrivo non facessero danni; ma i danni glieli fecero ugualmente in quanto, Goffredo a Filippopoli, dopo aver saputo della loro cattività, aveva chiesto la loro liberazione e giunto poi ad Adrianopoli aveva mandato a chiedere viveri, che Alessio gli aveva rifiutato; al che Goffredo gli dichiarò guerra e per otto giorni furono incendiati e devastati tutti i dintorni di Selibria, non molto distante da Costantinopoli; a questo punto l’imperatore decise di restituire gli ospiti e le devastazioni cessarono.
Comportandosi a questo modo, Goffredo di Buglione e Raimondo di Saint Gilles nel frattempo giunti a Costantinopoli, non avevano fatto altro (con i precedenti di Pietro l’Eremita), che acuire l’odio dei greci che li considerarono invasori, più civilizzati, ma più pericolosi dei peceneghi e dei polovizi dai quali Bisanzio aveva dovuto continuamente difendersi; essi erano divisi non solo da motivi religiosi: i cristiani infatti consideravano i greci eretici (i preti ortodossi erano sgozzati col pretesto di essere scismatici), i greci a loro volta non sopportavano il clero latino bellicoso e turbolento che fornito di armi, combatteva come i soldati; ma anche politici.
I greci infatti li considerarono anche avversari politici, in quanto mentre l’imperatore si aspettava che le conquiste fatte ai turchi di città e territori tolti precedentemente ai greci, fossero fatte per suo conto, essi non appena conquistavano questi territori, se ne impossessavano per proprio conto.
I CAVALIERI SI
RIUNISCONO
ALLE PORTE
DI COSTANTINOPOLI
|
G |
offredo con i suoi accampati fuori le mura di Costantinopoli, era stato ricevuto da Alessio che dovendo farli passare in Asia Minore chiese il giuramento di fedeltà che Goffredo gli rifiutò; peggio ancora Raimondo di Tolosa che disse che non era andato lì in cerca di un padrone; alla fine vennero tutti a miglior consiglio e Raimondo acconsentì al giuramento, ma solo nel senso che “non avrebbe intrapresa alcunché contro l’onore e la vita dell’imperatore, fintanto egli avesse adempiuto ai suoi doveri” (!), mentre per il giuramento di fedeltà (come vassallo) disse che “sarebbe morto prima prestarlo”.
Goffredo attendeva l’arrivo di Boemondo in modo che riunite tutte le forze poteva imporsi sull’imperatore il quale, intuito il suo pensiero diede disposizione alle sue truppe di andare ad appostarsi sul suo percorso, mentre attorno al campo dei crociati fece mettere un blocco consistente di soldati; Boemondo annunciava il suo arrivo con il saccheggio di molte città e l’imperatore che aveva dato ordine al suo generale di distruggere i crociati, si precipitò a fargli chiedere di risparmiare i suoi sudditi invitandolo a Costantinopoli e promettendogli di fargli vendere per strada tutti i viveri di cui avesse bisogno; gli mandò incontro Goffredo di cui Boemondo aveva gran rispetto, il quale gli suggerì di assecondare l’imperatore dal quale potevano ricevere aiuti, convincendolo di recarsi a corte.
Ricevuto con magnificenza “pari al timore che Alessio nutriva per lui”; nell’entrare nella sala Boemondo trovò una tavola imbandita con tutte le prelibatezze che poteva offrire Costantinopoli, ma ciò che lo sorprese fu di vedere tanti animali uccisi di fresco, quanti ne erano preparati pronti sulla tavola; gli fu riferito che non piacendogli la cucina greca, l’imperatore gli dava la possibilità di far preparare le vivande secondo i suoi gusti; questa però era una giustificazione apparente in quanto l’imperatore conoscendo la sua diffidenza, egli potesse sospettare che gli fosse somministrato cibo avvelenato... e infatti Boemondo mangiò ciò che si fece preparare dai suoi cuochi!
Alessio pensava di sedurlo con le lusinghe, portandolo nella sala del tesoro, facendogli vedere le sue ricchezze e promettendogli un territorio lungo quindici giorni di cammino e largo otto, al di qua di Antiochia e ottenne il giuramento di fedeltà come alla fine avevano fatto gli altri cavalieri, ad esclusione di Tancredi (nipote di Boemondo, come è stato detto, figlio della sorella Emma) più orgoglioso dello zio con il suo amico Riccardo si era rifiutato e con Roberto partono per proprio conto per l’Asia minore.
Giunta la primavera i crociati vennero trasportati sull’altra riva per gruppi; Raimondo fu trasportato in Calcedonia con Boemondo: gli altri erano andati ad accamparsi in una piana in prossimità di Nicea che era la capitale del regno del sultano Solimano (si trattava del sultano di Iconio che non rientra nella cronologia dei sultani ottomani v. in Cronologia I Sultani Ottomani ecc.), ed era una bella città fortificata con mura e trecento torri; con l’imperatore era stato concordato che una volta conquistata, la città gli fosse consegnata, mentre i vincitori avrebbero preso il bottino.
Il sultano che aveva capito le intenzioni dei crociati, era partito per raccogliere l’esercito e durante la sua assenza aveva scritto agli assediati di resistere in quanto sarebbe arrivato con un poderoso esercito; la lettera era stata intercettata e servì ai crociati per prepararsi alla resistenza; gli abitanti diffidavano dei crociati e preferendo arrendersi all’imperatore, avevano accettato la proposta di Butumite che in segreto aveva loro proposto condizioni vantaggiose.
Giunto il sultano e vi fu una grande battaglia (con duemila morti cristiani e quattromila turchi); i cristiani tiravano con le catapulte in città le teste dei turchi e all’imperatore mandarono mille teste; l’imperatore congratulandosi, mandò stoffe di seta ai principi e una somma da distribuire tra i soldati, dando disposizione che i viveri (che venivano portati nel vicino porto di Civitot) fossero venduti a basso prezzo.
Butumite con agenti segreti trattava con gli abitanti ai quali chiedeva di arrendersi all’imperatore che prometteva considerevoli ricompense e il più onorevole trattamento per la moglie, la sorella e i figli del sultano, rimaste in città; raggiunto l’accordo gli abitanti fecero entrare le truppe greche che si trovavano nei pressi e chiuse le porte, con trombe e acclamazioni di viva l’imperatore, furono issate sulle mura le bandiere imperiali con somma sorpresa dei crociati i cui soldati volevano dare ugualmente l’assalto alle mura ma furono sconsigliati dai loro capi; con il loro rammarico per la mala fede dell’imperatore che aveva preso la città con il loro sangue, si accontentarono di ricevere in ricompensa i prigionieri latini, avanzi della disfatta di Pietro l’Eremita e Galtiero Senzaveri; l’imperatore rimandò al sultano la mogli, la sorella e i figli, senza chiedere riscatti, mentre raddolcì i principi con doni e i soldati con distribuzione di danaro e viveri.
I CAVALIERI
SI APPROPRIANO DI
ANTIOCHIA CON L’AUSILIO
DELLA SACRA LANCIA E
DI EDESSA E TRIPOLI
|
B |
oemondo era stato traghettato con i suoi in Calcedonia, mentre gli altri crociati erano stati trasportati dall’altra parte del Bosforo (*) e dopo gli avvenimenti innanzi narrati, si misero in cammino dirigendosi verso Antiochia.
Le aspirazioni di Boemondo erano diverse da quelle degli altri crociati; infatti il piccolo principato di Taranto non gli bastava (già undici anni prima aveva tentato di impadronirsi dell’impero bizantino, come abbiamo visto, senza riuscirvi); egli aveva colto l’occasione della crociata, della quale non gli importava nulla, e aveva colto l’occasione per ritentare la fortuna ... che questa volta lo assistette.
L’esercito che si stava dirigendo ad Antiochia era formato dai vari capi crociati ciascuno con il proprio seguito unitamente a soldati bizantini comandati da un generale bizantino; quando giunsero ad Antiochia (luglio 1097) si trovarono di fronte a una bellissima città, considerata la perla dell’Oriente; circondata da oltre dieci chilometri di mura che racchiudevano quattro colline separate da un torrente che sfociava nel fiume Oronte; aveva circa quattrocento torri (il numero indicato varia da trecentosessanta a quattrocentocinquanta), con la cittadella che la dominava, trovandosi a circa quattrocentocinquanta metri di altezza; la città era circondata da un esteso territorio; signore della città era Yaghi Sivàn.
Ciascuno piantò il proprio accampamento davanti alla città; Boemondo si accampò davanti alla porta san Paolo, Ugo di Vermandois, Roberto Courteheuse, Roberto di Fiandra e Stefano di Blois fra la porta san Paolo e la porta del Cane, Raimondo di Tolosa e i provenzali, verso nordovest e Goffredo di Buglione con i lorenesi di fronte alla porta del Duca o del Giardino; così sistemati incominciarono a saccheggiare indiscriminatamente i frutteti che si trovavano nella campagna circostante, con spreco delle fonti alimentari (di un bue mangiavano solo le cosce e la spalla, pochi il petto), il grano e il vino li procuravano facilmente; l’assedio andava per le lunghe e la vita negli accampamenti tra vino, gioco, la novità della danza del ventre (ma per gli arabi è solo “la danza”) e donne, aveva raggiunto un tale degrado che Boemondo fatto riunire il consiglio di guerra fece decretare pene severe per gli adulteri, i fornicatori, gli ubriachi i giocatori e contro i disertori che non mancavano.
Boemondo perseguiva il suo disegno segreto di impadronirsi della città e conosceva il pensiero degli altri capi che non intendevano venir meno al giuramento di fedeltà fatto ad Alessio; egli riuscì a mettersi in contatto con un fabbro di corazze, di nome Firuz addetto alla difesa di una torre contigua al fiume che aveva una finestra che dava sulla valle, e dopo averlo corrotto con promesse di danaro e di un feudo fece entrare cinquecento dei suoi che all’alba (tra aprile e maggio 1098) diedero fiato alle trombe.
Yaghi Sivàn svegliatosi chiese cosa stesse succedendo, gli fu risposto che il suono veniva dalla cittadella che era stata presa (invece che dalla torre); preso da panico egli fuggì con trenta paggi; aveva percorso una ventina di chilometri quando ripreso il controllo si pentì di essersi messo in salvo invece di combattere e perdendo i sensi cadde da cavallo; i compagni volevano rimetterlo in sella ma Yaghi era troppo debole per montarvi e lo abbandonarono, lasciandolo per terra; si trovò a passare un taglialegna che gli tagliò la testa e la portò ai franchi.
La conquista non fu semplice si combatteva per conquistare le altre torri, Boemondo aveva preso il comando della città e dopo dodici giorni i soldati erano allo stremo della sete, della fame e del sonno e si nascondevano per dormire, con gli ufficiali che facevano suonare le trombe per chiamarli a combattere; e Boemondo aveva dovuto dar fuoco a interi quartieri per snidarli dalle case dove si erano rifugiati; la città era piena di cadaveri in putrefazione.
Occorreva qualcosa che li scuotesse e ogni giorno si diffondevano racconti di visioni e profezie; fra queste emerse un prete di Marsiglia (furbo matricolato, dicono i cronisti arabi), Pierre Barthélemy il quale si recò dai capi raccontando di aver avuto per tre volte la visione di s. Andrea il quale gli aveva detto di andare nella chiesa del fratello san Paolo, in Antiochia, di scavare presso l’altare maggiore dove avrebbe trovato il ferro della lancia che aveva trapassato il fianco di Cristo; fu creduto con scetticismo; or5dinò tre giorni di digiuno e poi si andò a scavare; dopo aver tolto le lastre del pavimento, si scavava ma il ferro non veniva fuori, poi fra’ Barthélemy scese nella buca e trovò il ferro che sporgeva (14 giugno)! (**).
All’esterno della città si trovavano accampati i musulmani guidati da Qawàm ad-dawla Kerbuqà (Keborga) giunto dalla Siria con l’esercito musulmano di turchi e arabi; costoro però avevano deciso di vendicarsi del loro capo che li trattava male; Boemondo approfittò del ritrovamento della sacra lancia per uscire con i suoi soldati e affrontare Kerbuqà che fu sconfitto per la defezione dei suoi soldati che si erano dati alla fuga, lasciando tutti i loro averi nell’accampamento di cui si appropriarono i franchi, e inseguiti, molti di loro furono massacrati.
Boemondo riunì il consiglio dei baroni ai quali fece presente che prendeva la città per sé, trovando la sola opposizione di Raimondo di Saint Gilles che proprio lui non aveva prestato giuramento all’imperatore; i capi quindi partirono, Goffredo si recò dal fratello a Edessa, Boemondo andò in Cilicia dove fu acclamato dai suoi principe di Antiochia.
In quest’epoca di sceicchi, ciascuno comandava nella propria città ed erano tutti in lotta tra di loro ma facilmente, quando si combattevano, chiedevano aiuto agli stessi capi cristiani; dalle parti di Antiochia vi erano alcune città (Malatia, Siwas e altre terre) il cui signore aveva chiesto aiuto a Boemondo contro Kumushtikin ibn ad-Danishmand Tailù; Boemondo vi si recò con cinquemila uomini, ma quando vi giunse, Kumushtikin se ne era già impadronito e vi fu una battaglia in cui Boemondo era fatto prigioniero; tenuto in cattività per due anni fu liberato dai franchi che pagarono centomila dinàr, (pari a 40,25 kg. d’oro).
Il nipote Tancredi aveva occupare Tarso, territorio che segnava il confine del principato di Antiochia con la Cilicia e alla morte di Boemondo gli succederà nel principato così ingrandito; anche Baldovino fratello di Goffredo, recatosi in Mesopotamia, si era impossessato di Edessa togliendola al governatore dell’imperatore e infine, anche quello che doveva essere il santo Sepolcro liberato, era divenuto il regno di Gerusalemme che si estendeva e confinava con la contea di Tripoli conquistata da Raimondo di Tolosa (morto nel 1105) che, per qualche anno era stata usurpata, ma poi era giunto (1109) il figlio Bertrando con un’armata provenzale, riprendendo la contea; con la formazione del regno di Gerusalemme questi nuovi feudatari prestavano il giuramento di fedeltà, non più all’imperatore, ma al re di Gerusalemme.
*) I PONTI SUL BOSFORO E IL TUNNEL E IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
A Istànbul (che conta quasi dodici milioni e mezzo di abitanti e un mln. e mezzo di pendolari), per smaltire il traffico tra le due rive, già collegate da due ponti (e se ne prevede un terzo!), è stata inaugurato (2013) sotto il Bosforo uno straordinario tunnel a prova di terremoto, con tecnologia giapponese, a circa sessanta metri di profondità, in totali 14 km, di cui 1,4 sotto il mare; il tunnel ha corsie sovrapposte per il passaggio di treni e auto, che assorbirà l’enorme traffico di pendolari; l’opera prevista nel 2005 da terminare nel 2008 è stata ritardata di cinque anni a causa di un ritrovamento archeologico (porto del IV sec.); in ogni caso per la sua costruzione sono stati impiegati otto anni, ciò che dimostra l’arretratezza del nostro povero Paese che dopo cinquant’anni (ma si può risalire anche al Regno di Napoli v. in Wikipedia) non sa ancora se farlo oppure no, ma avendo speso nel frattempo(con denaro pubblico) la stessa cifra della sua costruzione, distribuita tra i numerosi progettisti, addetti e funzionari, lautamente remunerati, secondo gli usi vetero-bizantini ereditati mentre l’isola manca ancora di ferrovie (che sono ancora con un solo binario), mancano pezzi di autostrade, i ponti crollano e pur essendovi acqua a sufficienza, gli acquedotti perdono nel percorso oltre il 50% e l’estate rimangono senza acqua, con rifornimento offerto a pagamento dalla mafia (così religiosa che alle processioni fanno inchinare la Madonna davanti alla casa del capomafia!).
Con tutto questo sfascio i deputati regionali e funzionari sono gratificati come lo erano quelli bizantini, con altissimi stipendi, il sistema previdenziale eroga le prestazioni anche a quelli che sono morti e la spesa di danaro pubblico è senza freni (con un buco di 35mld.!) ... mentre il lusso è sfoggiato alle soirèe del teatro Massimo di Palermo ... che mantiene una orchestra stabile!
Se questa è la situazione siciliana, l’Italia non ride: mentre infatti la stampa riempie le pagine dei giornali solo con le beghe tra i partiti (alcuni dei quali vogliono le elezioni subito - senza una legge elettorale, sulla quale non si mettono d’accordo perché ognuno vuol furbescamente prevaricare sugli altri!), ciò non fa che fuorviare il Paese dai veri problemi che sono la povertà in espansione e la inflazione, fatta passare per deflazione (*) argomenti di cui non si parla che invece dovrebbero essere tenuti continuamente in primo piano!
*) La differenza tra i due termini a molti sfugge, ma detta in due parole: con la deflazione l’economia è bloccata e la popolazione non spende danaro il cui valore rimane stabile; con l’inflazione non vi è produzione o essa diminuisce, mentre i prezzi dei prodotti e degli alimenti aumentano e il danaro perde valore: chi ricorda il costo della raccomandata a 150 lire? Ora una raccomandata, con l’ultimo aumento è arrivata a sette euro, vale a dire a quasi 15mila delle vecchie lire: ecco l’inflazione che fa ulteriormente aumentare la povertà!
**) Dagli esami fatti sulla lancia è risultato che il ferro risale a quell’epoca; il legato pontificio Ademaro accusò il frate di inganno e il frate volle sottoporsi alla ordalia, la prova del fuoco; alcuni dicono che si salvò, altri che morì dopo pochi giorni.
LA TRAGICACONQUISTA
DI GERUSALEMME
|
I |
l grande esercito crociato, falcidiato, era ridotto a ventimila uomini e millecinquecento cavalieri, preceduto da una massa di fanatici detti “tafuri” che seguivano Pietro l’Eremita, scalzi, senza armi con i soli bastoni ma incutevano terrore per la loro ferocia in quanto massacravano gli avversari senza pietà e ne mangiavano la carne; quando i crociati cristiani, dopo varie vicissitudini (che racconteremo separatamente) erano giunti a Gerusalemme (dicembre 1098) assetati e affamati con gli animali che morivano di fame e di sete, rimasero in queste condizioni per dieci giorni fino a quando giunsero i rifornimenti da parte di navi genovesi e inglesi.
Tra il 14 e 15 luglio (1099) riuscirono entrare nella città in cui si trovavano settemila abitanti musulmani oltre alla guarnigione, tutti passati a fil di spada comprese donne e bambini; in questo giorno da ricordare nelle pagine nere della storia del cristianesimo, i cavalieri (tra i quali vi erano molti ecclesiastici armati) riempirono le strade di Gerusalemme di mucchi cadaveri che i cavalli calpestavano per inseguire i fuggitivi; i cronisti sono concordi nel riferire (Michaud, cita Raimondo d’Agiles, testimone oculare), che sotto il portico e nella moschea di al-Aqsa il sangue arrivava alle ginocchia e anche al morso del cavalli (erano state uccise più di settantamila (*) persone, imam compresi e predati quaranta candelabri d’argento ognuno del peso di tremilaseicento dramme e un grande lampadario d’argento del peso di quaranta libbre siriane e ancora centocinquanta candelabri più piccoli d’argento e più di venti d’oro, con altri innumerevoli oggetti preziosi)... anche la sinagoga in cui si erano rifugiati gli ebrei fu data alle fiamme; dopo di che fu fatta la processione di ringraziamento dei crociati con Goffredo di Buglione (che non aveva partecipato alla carneficina), tutti a piedi nudi!
Voltaire in proposito scrive che “questa tenerezza che era stata manifestata con il pianto non era per nulla compatibile con lo spirito di vertigine, di furore di violenza e sopraffazioni: lo stesso uomo può essere furioso e tenero ma non nello stesso tempo”!
Goffredo non volle prendere il titolo di re di Gerusalemme preferendo quello di “Difensore del Santo Sepolcro” che tenne per un solo anno in quanto egli morì, secondo fonti arabe, colpito da una freccia durante l’assedio di Acri (1100) e non di malattia come riferiscono le fonti occidentali, e gli succedette come primo dei re di Gerusalemme il fratello Baldovino (1100-1118).
*) La cifra, di fonte araba, non è da considerare reale, come d’altronde quelle indicate dai cronisti occidentali
FINE
PRIMA PUNTATA